Articoli riportati nel seguito:
LA FIGURA DI COSTANTINO NIGRA SULLA STAMPA CATTOLICA DEL RISORGIMENTO
UN DIPLOMATICO OTTOCENTESCO A CACCIA DI CANZONI
I CANTI POPOLARI DEL PIEMONTE
UN CANAVESANO GRANDE DIPLOMATICO E LETTERATO DI ECCEZIONALE CULTURA
-------------------------
LA FIGURA DI COSTANTINO NIGRA SULLA STAMPA CATTOLICA DEL RISORGIMENTO di Carlo Bovolo

Leggendo le note di copertina dei dischi di musica folk, spesso capita di trovare accanto al titolo del brano diciture come «Nigra 3» oppure «Child 10». Si tratta della numerazione progressiva delle ballate pubblicate in due opere fondamentali: i Canti po- polari del Piemonte, raccolti da Costantino Nigra e pubblicati nel 1888; e The English and Scottish Po- pular Ballads, raccolte dallo studioso statunitense Francis James Child e pubblicate in cinque volumi tra il 1882 e il 1898.
Costantino Nigra nacque nel 1828 a Villa Castelnuovo, oggi Castelnuovo Nigra, in provincia di Torino, e fece una brillantissima carriera diploma- tica rivestendo un ruolo determinante nella politica estera italiana, per il completamento del processo di unificazione dell’Italia dopo la morte di Cavour, avvenuta nel 1861. Fu ambasciatore italiano a Pa- rigi (1860), San Pietroburgo (1876), Londra (1882) e infine Vienna (1885). In parallelo all’attività diplo- matica coltivò una grande passione per la ricerca letteraria, per i dialetti del Piemonte, per gli studi lin- guistici, in particolare riguardo alle lingue celtiche e romanze, tramite un fitto epistolario con intellettuali dell’epoca, ai quali chiedeva in prestito o in acqui- sto volumi e manoscritti con cui arricchire la sua già vastissima biblioteca.
Se i Canti popolari del Piemonte sono stati pubblicati in forma definitiva nel 1888, le prime raccolte datano fin dal 1854. Oggi esistono dei Canti due principali edizioni: quella più comune è il Reprints Einaudi in due volumi, del 1974; l’altra è la splendida edizione Einaudi del 2009, arricchita con un’introduzione del decano degli etnologi italiani, Alberto Cirese, e un saggio dei curatori Franco Castelli, Emilio Jona e Alberto Lovatto. Si tratta un unico volumone di un chilo e mezzo di peso, carta sottilissima, purtroppo praticamente introvabile se non a cifre folli. Molto importanti sono i 2 CD allegati, messi a punto dagli stessi curatori, che presentano un’antologia di esecuzioni delle canzoni del Nigra e delle loro varianti, recuperate negli ultimi decenni dalle voci di coloro che ancora le conoscevano ed erano in grado di cantarle; talvolta anziani nati nel 1890!
Nigra scrisse nella sua prefazione della raccolta del 1888: «Quando io cominciai le prime pubblica- zioni di canzoni popolari piemontesi (1854-60), gli studi sulla poesia popolare comparata o non esistevano o cominciavano appena. […] Io fui il primo a in- dicare chiaramente l’identità d’una numerosa serie di canti popolari che sono comuni ai paesi romanzi, aventi substrato celtico, e che non esistono negli altri paesi romanzi, cioè nell’Italia media ed inferiore e nella Spagna Castigliana.» (Nigra 1974, p. XXVII)
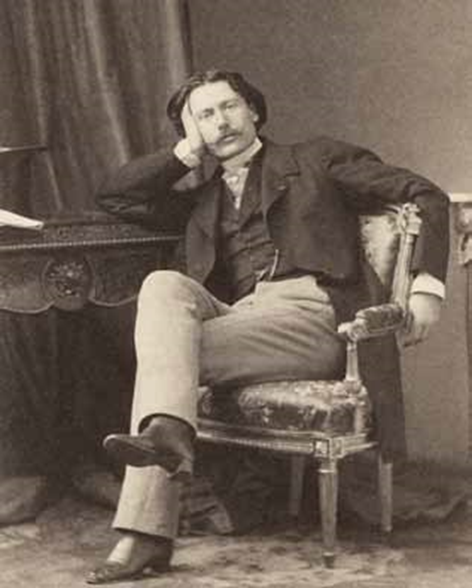
Costantino Nigra, 1860 ca., Bibliothèque nationale de France
Egli dedicava scarsa attenzione all’aspetto musi- cale del canto e infatti, per la maggior parte delle canzoni, degli strambotti, dei canti religiosi e infantili, manca la trascrizione della musica. Delle 153 ‘canzoni’ che lui commentò confrontando oltre cinquecento diverse lezioni, riporta solo 15 linee melo- diche, in forma striminzita: è una caratteristica co- mune alle raccolte ottocentesche.
Lo studioso Giuseppe Cocchiara scrisse inoltre nella sua prefazione ai Canti apparsa in occasione della prima edizione Einaudi del 1957: «Ma al Nigra non interessa tanto il valore poetico dei canti che ha raccolto, quanto la tradizione che li sostiene. Egli ha compreso che la poesia popolare non è soltanto un saggio poetico, ma anche un documento etnografico con una sua tradizione culturale. Nella poesia d’arte un testo è fine a se stesso, chiuso e defini- tivo; nella poesia popolare invece, esso per vivere una sua vera vita, deve modificarsi continuamente, e dare origine ad altri testi.» (in Nigra 1974, p. XIV) Si dovrà attendere il 1934 e la relazione di Michele Barbi al III Congresso nazionale di arti e tradizioni popolari a Trento, perché l’importanza della musica venga posta con forza all’attenzione: «Grave danno per lo studio e la valutazione della poesia popolare è stato l’averla sempre considerata disunita dalla melodia. Non esiste poesia propriamente popolare, metodo di raccolta dei canti: «I componimenti qui pubblicati furono […] trascritti dal canto o dalla det- tatura, per lo più di contadine, che facevo ripetere, semprecché potevo, due o tre volte, e in epoche diverse. (Nigra 1974, p. XXXI) E ancora: «Sotto ciascuna lezione sta scritto il nome, se conosciuto, della persona che la cantò, la dettò o la trascrisse, non che il nome del luogo in cui fu cantata, dettata o trascritta.» (id., p. XXVIII)
Una passione di Nigra fu la ricerca storica dell’origine di queste ballate, teorizzando che se descri- vono un fatto molto antico, anche la ballata stessa deve essere antica. L’esempio è dato dalla famo- sissima “Donna lombarda” (Nigra 1), per la quale ipotizza che si possa risalire all’età longobarda, alla vicenda e alla leggenda del re Alboino e di Rosmun- da (evocate nella nota frase «Bevi Rosmunda dal teschio di tuo padre» ripresa da una parodia gio- vanile di Achille Campanile). Un’ipotesi contestata dagli studiosi del ’900.
Le ricerche del Nigra sono estremamente affascinanti, per ogni ballata si cerca una comparazione tra varie versioni disseminate in tutta Europa. Il suo lavoro ha una tesi di fondo che va oltre la parte mu- sicale e si riallaccia al suo ruolo di diplomatico, di protagonista dell’Unità d’Italia. Così scrive: «L’Italia rispetto alla poesia popolare (come rispetto ai dialetti) si divide in due zone: Italia inferiore, con substrato italico; e Italia superiore, con substrato celti- co.» (id. LXVI-LXVII)
Un volume del 2011, Costantino Nigra etnologo a cura di Piercarlo Grimaldi e Gianpaolo Fassino, raccoglie gli atti di un convegno di studi del 2008 organizzato per il centenario della morte. In esso c’è, tra gli altri, un intervento di Domenico Scafo- glio dal titolo “Le due Italie di Nigra ovvero come si è costruita l’identità nazionale” (pp. 115-120), che sintetizza: «Nel pensiero di Nigra la lingua è stret- tamente connessa alla struttura biosichica delle singole razze e perciò diverse lingue non rinviano semplicemente a diverse culture, ma, prioritaria- mente, a diverse situazioni biologiche.» È evidente che la divisione dell’ItaIia in due aree etnicamente e linguisticamente distinte poteva entrare in contrasto con il processo di unificazione e perciò, fino aI 1870, quando Roma divenne capitale, Nigra ed altri stu- diosi ne tacquero. Nell’edizione dei Canti del 1888 il termine ‘razza’ non viene più utilizzato. Cocchia- ra nel 1952 scriverà in Storia del folklore in Europa che «per lui il concetto stesso di razza contempla esclusivamente quelle che sono le attitudini natu- rali, morali, intellettuali e artistiche di un popolo.» (Cocchiara 1971 [ed. or. 1952], p. 369) Una discus- sione spinosa, chiusa da Roberto Leydi nel 1973 in I canti popolari italiani: «[…] oggi ci rendiamo per- fettamente conto che dietro l’impegno di sistemazione filologica di Costantino Nigra c’era anche la sottintesa preoccupazione di fornire un supporto al privilegio piemontese sulle altre regioni del giovane Regno d’Italia (dimostrando la vocazione epica e civile dei sudditi sabaudi di fronte alla vocazione lirica e amorosa dei cittadini meridionali, rudi cantori di ballate i primi, vaghi stornellatori i secondi)» (p. 14). Una contrapposizione quindi tra ballata al Nord e lo strambotto/stornello al Centro-Sud. Tanto che Nigra chiude il volume dei Canti con una piccola raccolta di “Strambotti e stornelli” alla quale, dopo tanta ab- bondanza di ballate, non fa caso nessuno. Eppure, sempre negli atti del convegno del 2008, un intero capitolo è dedicato a “Lo strambotto piemontese: un genere di canto ingiustamente trascurato” di Franco Castelli (pp. 211-240): un canto in una strana lin- gua non propriamente dialettale, maccheronica, un linguaggio definito «erotico plebeo», cantato quasi prevalentemente dalle donne.
Arriverà poi la guerra del 1915-1918, che metterà nelle trincee uomini provenienti da tutte le parti d’I- talia, ciascuno con i suoi canti, che saranno spunto per canti tragicamente nuovi. Il volume del Nigra resta in ogni caso una miniera cui hanno attinto in molti, ai quali è stata data la libertà di modificare i testi e di creare musiche. Per quanto riguarda la parte degli strambotti piemontesi, in particolare, consiglio l’ascolto del CD del gruppo di folk revival della Ciapa Rusa, Stranòt d’amur: canti e danze dell’Alessandrino del 1984. Una bella serie di can- zoni e musiche popolari del Piemonte si trova anche qui: www.teche.rai.it/2014/11/archivio-del-folclore- musicale-italiano-piemonte/. Nella prossima pun- tata parleremo delle ballate, della figura di Teresa Viarengo e delle varie versioni contemporanee.
I CANTI POPOLARI DEL PIEMONTE di Alessandro Vitale Brovarone

Sia pure in una angusta prospettiva critica e metodologica, l'attività di ricerca e studio dei canti popolari dell'Italia nordoccidentale precedette di parecchi anni la pubblicazione dei Canti popolari del Piemonte di Costantino Nigra[1], e ne accompagnò la stesura e l'elaborazione, protrattasi almeno dal 1854 al 1888.
Di questa attività, cui il Nigra riconosce il suo debito[2], è rimasta soltanto, a quanto mi consta, una tenue traccia di Canti popolari Umbri, Liguri, Piceni, Piemontesi e Latini di Oreste Marcoaldi[3]. Il Marcoaldi, marchigiano, si servì a sua volta principalmente, per la parte ligure e piemontese, di una raccolta manoscritta di Domenico Buffa, risalente approssimativamente agli anni '40. Tale raccolta, sappiamo ancora dal Marcoaldi, era passata attraverso le mani del Tommaseo, che stava allora raccogliendo materiali per una raccolta di canti popolari di tutte le province italiane[4].
Ma i debiti e le riconoscenze del Nigra vanno oltre:
«Un'altra parte considerevole della collezione [oltre quella costituita dai canti raccolti personalmente], mi fu trasmessa o rimessa da molti collaboratori, alcuni dei quali portano un nome ben noto in Italia. Giovanni Picchia, l'illustre professore di sanscrito nell'Università torinese, mi diede, fin dal 1853, una raccolta di canzoni da lui trascritte in Torino sotto la dettatura di Giuseppina Morra-Fassetti. Domenico Carbone, già compagno di studi e d'armi, non mai abbastanza compianto, mi diede, nel 1858, le canzoni da lui raccolte nel suo nativo villaggio di Carbonara presso Tortona. Domenico Buffa, noto non solo nel campo letterario, ma ben più nella storia politica del nostro paese, mi fece dono, egualmente nel 1858, del suo manoscritto di canti popolari piemontesi e liguri da lui raccolti, dal 1842 al 1845, dal quale Oreste Marcoaldi trasse tutta la parte ligure e piemontese della sua collezione, e in cui mi rimase pur qualche cosa a spigolare. Parenti, amici e colleghi trascrissero per me molte lezioni in varie parti del Piemonte: Teresa Croce, già nominata, in Sale-Castelnuovo nel Canavese; Emerenziana Nigra-Vegezzi-Ruscalla, e Adele Bolens sulla collina di Torino; Enrichetta Cassone in Moncalvo-Monferrato; Felice Oddone in Bra; Luigi Bassi in Mondovì, Torino e Pinerolo; Carlo Franchelli, morto sui campi di battaglia a San Martino, nella campagna di Torino; G. B. Gandino in Bra e Mondovì; Bernardo Buscagliene in Graglia presso Biella; Garnerone in Lanzo Torinese; D. Monetto in Montaldo di Mondovì; Gaudenzio Caire in Pinerolo e Novara; Giuseppe Rossi in Saluzzo; Pietro Fenoglio in Bene-Vagenna di Mondovì; G. B. Amidei in Paesana, Lagnasco, e Val di Po, circondario di Saluzzo; Annibale Strambio in Rocca d'Arazzo, circondario d'Asti. E finalmente due buone collezioni mi furon trascritte, una da Nicolo Bianco in Val-fenera d'Asti, e una da Tommaso Borgogno a La Morrà, circondario d'Alba in Monferrato, mentre egli era colà giudice di mandamento. Qualche canzone mi fu pure trasmessa da Giuseppe Regaldi da Parma, da A. Berti da Venezia, da Cristoforo Pasqualigo da Lonigo nel Vicentino, da Gabriele Rosa I da Brescia, da Alessandro D'Ancona da Pisa; altre da altrove »[5].
L'ingresso, a mio giudizio molto profìcuo, in questa «zona d'ombra» della cultura piemontese pre-unitaria, ci è reso possibile dal Nigra stesso che si preoccupò, con l'onestà scientifica che ha lasciato grande impronta nei Canti popolari del Piemonte, di render pubblico il materiale di cui si era servito. Il Nigra infatti inviò in dono alla Biblioteca Nazionale di Torino un pacco contenente una buona parte delle raccolte manoscritte che gli abbiamo visto ricordare. I fascicoli e i fogli inviati dal Nigra furono poi legati e sono tuttora conservati tra i manoscritti della Biblioteca Nazionale con la segnatura R III 7.
Il materiale è preceduto da una lettera di accompagnamento di mano del Nigra:
«Signor Prefetto - Venezia 24 Febb. 1904
Mi pregio di mandare in dono alla Biblioteca Nazionale di Torino un piccolo pacco di Canti popolari principalmente dell'Alta Italia, manoscritti, raccolti da:
Giovanni Picchia - E.a Cassone - Regaldi Dal Medico - Gaudenzio Caire - Cav. Strambio - Dott. Nicolo Bianco - Domenico Buffa - Domenico Carbone - Herm. Kestner.
Furono questi canti in massima parte pubblicati da me e da altri. Alcuni sono inediti, o almeno presentano varianti inedite. Ad ogni modo sono documenti sinceri, utili a consultarsi da chi si occupi di studi folklorici; e sarebbe ora difficile il trovarli ancora, in parte almeno, sulla bocca del popolo.
Gradisca, Signor Prefetto, l'espressione della mia distintissima considerazione C. Nigra»
II quadro presentatoci dal Nigra — ma, teniamo conto, un Nigra ormai molto avanti con gli anni - è, a mio avviso, pessimistico. Infatti, come ho potuto constatare attraverso uno spoglio integrale del materiale ed un confronto con i testi editi dal Nigra e dal Marcoaldi, una buona parte del materiale è inedita.
Il manoscritto è composto da[6]:
a) 1 lettera d'accompagnamento (ined.) — b) 4 quaderni di Canti popolari in varii dialetti d'Italia raccolti per opera di Domenico Buffa (rispettivamente: 1) Genova: 5 canzoni, 2 edite dal Marcoaldi e 2 edite dal Nigra; di esse una è edita dal Nigra e dal Marcoaldi; inedite 2. - 2) Porto Maurizio: 29 strambotti dei quali 6 editi dal Marcoaldi; inediti 23. - 3) Orba: 122 strambotti e 1 canzone; 28 editi dal Marcoaldi, 7 editi dal Nigra; inediti 88 e 1 canzone. — 4) Ovada: 108 strambotti e 8 canzoni; degli strambotti 28 sono editi dal Marcoaldi, 10 dal Nigra; inediti 70. Delle canzoni 4 sono edite dal Marcoaldi, 2 dal Nigra; inedite 2. Inoltre si hanno 2 strambotti raccolti ad Ovada, ma da un informatore Veneto, inediti. — 5) Alessandria: 79 strambotti e 17 canzoni. Degli strambotti 22 sono editi dal Nigra, 37 dal Marcoaldi, 1 dal Nigra e dal Marcoaldi; inediti 21. Delle canzoni 2 sono edite dal Nigra, 9 dal Marcoaldi, ma senza le varianti date dal Buffa; inedite 6. -6) Oleggio: 7 canzoni di cui 6 edite dal Marcoaldi; 1 inedita. - 7) Rocca di Cerio (Canavese): 9 strambotti e 1 canzone. Degli strambotti 5 sono editi dal Marcoaldi, 1 dal Nigra; inediti 3. La canzone è edita dal Nigra. - 8) Rocca d'Arazzo: 1 canzone inedita). — e) Canson Piemonteise raccolte da Giovanni Flechia e da lui trasmesse a me. C.N. (1853): 27 canzoni, 14 edite dal Nigra; inedite 14. — d) Strambotti (detti notturni) raccolti in Moncalvo, Easso Monferrato da Enrichetta Cassone. 17, di cui 7 editi dal Nigra; inediti 10. — e) Donna lombarda raccolta a Parma da Regalai. Edita; inedita la lettera di accompagnamento. — /) Donna lombarda raccolta a Venezia da Dal Medico. Edita; inedita la lettera di accompagnamento. — g) Canzoni popolari di Novara, raccolte da G. Caire. 12, di cui 7 edite dal Nigra; inedite 5. — h) Canzone veneziana raccolta da G. Vallo. Inedita. — i) « Strambotti che si cantano dai contadini di Rocca d'Arazzo, provincia d'Asti » racc. dal Cav. Strambio (1850-1860). 144 strambotti, di cui 6 ripetuti, 50 editi; inediti 88. — ;) Strambotti - Valienerà (Asti) racc. dal Sig. D.r Nicolo Bianco (1850-1860). 24, di cui 6 editi dal Nigra; inediti 18.
Lettera di H. Kestner contenente alcune melodie, con lettera d'accompagnamento di Bunsen, da Torino. Segue altra comunicazione di H. Kestner a Nigra, Alcune delle melodie mi risultano inedite. — /) Canzoni e strambotti raccolti da Domenico Carbone a Tortona. 17 canzoni, di cui 11 edite dal Nigra, 6 inedite; è allegata una lettera di Silvio Lessona. — m) Strambotti, Carbonara presso Tortona. D. Carbone. 76 strambotti, di cui 42 editi dal Nigra; 34 inediti.
Risultano in questo modo inediti, nel complesso, 38 canzoni, 357 strambotti e alcune melodie. È lecito, a questo punto, chiedersi come mai il Nigra abbia indicato come editi tanti testi che risultano invece inediti. Osservando innanzi tutto come la maggior parte dei testi inediti contenuti nelle nostre raccolte sia costituita da strambotti, e soprattutto di provenienza monferrina, possiamo proporre diverse interpretazioni: innanzi tutto che il Nigra ritenesse, anche implicitamente, il concetto di «variante» come proprio della canzone epico-lirica, e non estendibile allo strambotto, e vedesse dunque come esaurienti le raccolte del Marcoaldi, del Ferraro[7] e la sua; che vedesse, scendendo via via per il Monferrato, attenuarsi le sue competenze a vantaggio del Ferraro; che infine ritenesse «scomoda » la grande quantità di strambotti, raccolta dal Buffa, ai fini della dimostrazione della sua tesi, che, come è noto, indica la canzone epico-lirica come tipica del canto popolare del settentrione, attribuendo invece al canto lirico mono-strofico, e dunque anche allo strambotto, una origine meridionale.
Certamente la validità del lavoro del Nigra non viene posta in discussione da queste omissioni, d'altra parte riconosciute implicitamente dal Nigra stesso[8]; tuttavia mi pare che si imponga, a questo punto, una ricognizione, il più possibile completa, sia sul terreno, sia sui documenti lasciatici da raccoglitori del secolo scorso e depositati in biblioteche o archivi pubblici, come i nostri,o privati, come quelli segnalati dal Costa[9].
Un ampio lavoro di raccolta orientato in questo senso credo possa chiarire, oltre che il problema dello strambotto in sé, anche i più generali problemi di tradizione, diffusione e invenzione del canto popolare: attraverso un confronto morfologico e tematico di canti popolari raccolti in momenti diversi e, almeno nel nostro caso, con la certezza della non dipendenza dalla fonte ottocentesca scritta dei canti registrabili ora (come potrebbe essere successo per alcuni tra i Canti popolari del Piemonte del Nigra) sarà possibile individuare due status successivi che potranno dare positive indicazioni sulle linee di trasmissione e sulle innovazioni nel canto popolare.
È certo comunque che i dati fornitici dai raccoglitori ottocenteschi non sono di per sé confrontabili con quelli raccolti ora; le diversità sia di prospettiva storico-critica, sia di metodo di rilevazione, possono da un lato aver guidato scelte e esclusioni ora non accettate, e d'altro lato possono aver compromesso sensibilmente il dato linguistico.
Si pone dunque la necessità di una riscoperta, il più possibile completa, delle nostre più antiche raccolte di canti popolari, intesa a porre in luce, oltre che una buona quantità di materiali, tutto un complesso di atteggiamenti che devono essere tenuti presenti ai fini di un corretto impiego, in prospettive critiche diverse da quelle ottocentesche, dei materiali stessi.
A questo vuol contribuire la pubblicazione di una parte dei testi che ho segnalati.
Dovendo trarre qualche dato che possa illustrare la qualità dei materiali reperibili nel manoscritto notato, mi pare che la scelta debba cadere (come ritengo si possa avvertire dalle pagine precedenti) sulla raccolta del Buffa, per diversi motivi: innanzi tutto per la sua ricchezza; per la zona che essa prevalentemente copre (dalla Liguria fino all'Alessandrino e al Monferrato meridionale), zona fra le meno esplorate dal punto di vista folklorico e dialetto-logico; infine, e soprattutto, perché da questa raccolta emerge la figura di un ordinatore che, sia pure con molte ingenuità, ha dato prova di un impegno certamente non episodico e superficiale.
Fra la grande quantità di materiale raccolto dal Buffa è necessario però operare una ulteriore scelta e credo sia opportuno limitare la nostra attenzione agli strambotti raccolti ad Ovada che mi pare possano porre in rilievo l'importanza di una zona di incontro e di scambio culturale e linguistico.
Riporto ora i testi raccolti dal Buffa presso Ovada, con le sue note a carattere linguistico e culturale, compresi quelli già inseriti nelle raccolte del Marcoaldi e del Nigra, sia per mantenere intatto l'aspetto storico-culturale della raccolta del Buffa, sia per sanare i guasti di trascrizione, un po' italianizzata dal Marcoaldi, e invece piemontesizzata dal Nigra. Riporto inoltre i criteri di trascrizione usati dal Buffa, che oltre alla loro utilità pratica, possono risultare un ottimo punto di riferimento per la conoscenza degli strumenti del raccoglitore.
pagg. 1-2
AVVISO - Tutti i vari dialetti ai quali appartengono i canti seguenti prepongono al verbo certe vocali, che fanno le veci di pronomi personali: talché questi possono essere omessi, e lo sono infatti il più delle volte nel parlar comune. Non tutti però questi dialetti usano le stesse vocali, ma a un dipresso le stesse. Eccole:
Sing.
a diggu (dico)
i-'t dixi (in alcuni dialetti a 't)
u dixe, e nel femm. a dixe
Plur.
a dimmu (diciamo) altri dialetti i
i dì
i dixu (altri a)
Se queste vocali siano una corruzione degli stessi pronomi, non so: certo l'i della 3a persona plurale par che venga dal latino illi e più immediatamente dal francese ils: e ne dà pure indizio il dialetto piemontese che nella 1a persona sing. usa i' invece di a. Quel che io so dire è che esse non possono mai essere tralasciate, neanche quando si usano i pronomi.
Per la più facile intelligenza dei dialetti nota anche l'uso che essi hanno frequentemente di por due esse dove nell'italiano cade la zeta, e l'altro di mutar spessissimo l'o in u, specialmente nelle finali.
Perché ad ogni dialetto non si mutasse ortografia (il che avrebbe impicciato non poco i lettori) fui obbligato a farmene una generale, da applicarsi a tutti, ed è la seguente:
u, si pronuncia all'italiana. — ü, alla francese. — ë, come un'e molto larga. — ö, come la eu francese. Quando la vocale che ha sopra le due virgolette richiede accento, io muto quelle in due accenti, così amë * (amare), virtü (virtù), andrö (anderò). — sc **, come la ch francese. Qualcuno penserà che a tal uopo avrei dovuto, usare la ch francese, come già conosciuta: ma l'inconveniente sarebbe stato maggiore, perché, come avrei dovuto allora scrivere la ch italiana? per es. nella parola masc-che (guancie)? l'accento circonflesso che servisse d'unione fra le due consonante era anche necessario perché ad ogni poco non nascessero dubbi sulla pronunzia, come in scacca, scurté, tasctu, ed infinite simili. — x, come la j francese. — 's, come la s italiana nella parola rosa. Questa esse è in molti dialetti sostituita sovente alla zeta italiana.
È anche da notarsi che i dialetti dell'Orba e d'Ovada (i quali, provenendo dal genovese, hanno come questo la più parte dei vocaboli non tronchi) usano troncarli tutti senza distinzione qualora cadano in parte del periodo che dette intiere allungherebbero troppo, o non renderebbero armonia. Perciò nei lor canti s'incontreranno talvolta parole che parranno nuove e non saranno che le già vedute e spiegate altrove, colla sola differenza del mancarci la finale.
[1] Torino 1888. Se ne veda però ora una nuova edizione con prefazione di G.Cocchiara, Torino 1957.
[2] Op. cit., pp xxxi-xxxxiii
[3] Genova 1955
[4] Confronta O. Marcoaldi, Canti popolari umbri etc opera citata nel testo
[5] C.Nigra, op cit, pp xxx1-xxxii
[6] I titoli, salvo le lettere, sono quelli dati dai raccoglitori o dal Nigra.
[7] Canti popolari del bassso Monferrato,Palermo, 1888; Canti popolari monferrini, Torino-Firenze 1870; I Canti popolari del Monferrato, Firenze, 1872; Superstizioni, usi e proverbi monferrini, Palermo, 1866.
[8] C.Nigra, op cit, p.xxix: "La raccolta si chiude con una piccola raccolta di Strambotti e Stornelli, nello scegliere i quali mi studiai di escludere quelli che fossero già stati pubblicati da altri, salvo poche eccezioni giustificate da varianti meritevoli di qualche attenzione».
[9] E.Costa, Tommaseo, Nigra e la - Raccolta di canzoni popolari- di Domenico Buffa in Archivio storico del Monferrato, 1 (1960), pp 107-141.
"Un canavesano grande diplomatico e letterato di eccezionale cultura" di Roberto Favero
1° articolo: Costantino Nigra: una vita al servizio del proprio paese
Introduzione
Nonostante le innumerevoli testimonianze che ne certificano l’eccezionale valore come diplomatico ( e i diplomatici italiani lo hanno scelto come Padre della Diplomazia Italiana, intitolandogli l’Associazione Nazionale dei Diplomatici a riposo), non solo, moltissime ne ribadiscono il valore anche come poeta, come studioso della canzone popolare, come glottologo ed etimologo, come studioso di lingue e dialetti e molto altro ancora.
Nonostante tutto ciò questa grande figura di Canavesano ancora non è entrata nella coscienza del territorio, nella memoria dei cittadini, nella consapevolezza che è un uomo di questa terra, straordinario, intelligente, politicamente eccellente, europeista ancor prima che l’Europa fosse costituita come Comunità.
Mi sono sempre chiesto il perché di questa situazione e ancora non sono riuscito a darmi una risposta.
Cavour ha scritto di lui: “ Nigra ha più talento di me, conosce perfettamente le mie intenzioni e le sa eseguire come nessun altro” e basterebbe questa affermazione a farne capire il valore, a farci capire come Nigra non solo è stato “il segretario di Cavour”, come la storia patria lo definisce, ma è stato uno dei protagonisti del processo unitario del nostro Paese, come braccio destro di Cavour prima e, dopo la morte di Cavour avvenuta nel 1861, come colui che ha contribuito a realizzarne il grande sogno, quello di fare dell’Italia una nazione unita, evento che si è concretizzato soltanto nel settembre del 1870.
Poi successivamente la sua eccezionale carriera di Ambasciatore nelle grandi capitali europee, dopo Parigi dal 1860 al 1875, San Pietroburgo nel 1876, Londra nel 1883 ed infine Vienna nel 1885 ne ha fatto apprezzare la sua preparazione politico-diplomatica in tutta Europa, dove ha tenuto alto il blasone del nostro Paese facendogli assumere il ruolo di Grande Potenza alla stessa stregua dei Grandi Imperi del Continente, la Francia, la Prussia, l’Austria, il Regno Unito.
Quella di Nigra è stata una vita interamente dedicata dedicata all’Italia, al Suo amato Paese, quello per il quale combatté volontario nella guerra del 1848-49, ed a cui dedicò tutte le sue energie durante oltre 40 anni di dedizione professionale, sacrificando la propria vita privata al supremo interesse dello Stato, un esempio che i nostri politici di oggi dovrebbero assumere come esempio di comportamento conforme all’ideologia parlamentare ideale.
Al fianco di Cavour
Fu Massimo D’Azeglio che lo scoprì, quando lo ebbe, da Presidente del Consiglio, come segretario personale nel 1851, ma fu Cavour che lo valorizzò, lo fece Capo del suo Gabinetto e lo volle sempre con sé nei dieci anni in cui sviluppò quel sogno ardito dell’unificazione dell’Italia!
Certo Nigra gli dava l’aiuto di cui Cavour necessitava: consigli, suggerimenti, presenza nei contesti difficili della diplomazia europea, riflessioni e osservazioni della situazione politica nazionale ed internazionale. Cavour lo portò con sé a Parigi e Londra, in visita agli alleati del Regno di Sardegna nella guerra di Crimea, Francia e Inghilterra; poi lo fece partecipe dei segreti del suo incontro con Napoleone III a Plombiéres nel luglio 1858, e infine gli affidò la missione segreta di trattare l’alleanza con l’Impero di Francia per la guerra contro l’Austria (la seconda guerra di Indipendenza) tra il settembre 1858 ed il marzo 1859.
Ne parla pochissimo la storia d’Italia di questa fondamentale missione segreta, ma se si pensa che tutto questo processo, maturato in oltre sei mesi di permanenza continua del Nigra a Parigi, a diretto contatto con Napoleone III, fu documentato da una Speciale Commissione in ben 4 corposi volumi pubblicati nel 1926, in cui furono raccolti tutti i relativi documenti epistolari col nome “Carteggio Cavour-Nigra”, ci si può rendere conto come la trattativa per l’alleanza avesse richiesto non soltanto tempo e fatica, ma anche una capacità di negoziatore politico non comune.
Questa considerazione la scriverà successivamente il Ministro della terza Repubblica francese, Emile Ollivier, che di Nigra dirà: “Nigra riuniva ad una grazia e flessibilità seducente la più chiara fermezza di spirito. Quando si negoziava con lui, in un primo momento si sarebbe potuto credere che egli avrebbe ceduto su tutto, tanto sembrava preoccupato di non ferire alcuno; ma quando si giungeva al punto decisivo della discussione, d’un tratto la sua figura diventava grave, i suoi occhi fissavano con una penetrazione ferma e là dove voi avevate sperato di trovare una debolezza incontravate una irriducibilità”.
In tutta questa fase Nigra fu anche incaricato di trattare il matrimonio tra la primogenita di Vittorio Emanuele II, Maria Clotilde (15 anni), con il cugino dell’Imperatore, Gerolamo Napoleone (33 anni); un matrimonio voluto fortemente da Napoleone III, come sigillo dell’alleanza tra l’impero di Francia ed il Regno di Sardegna, clausola che allora era ritenuta basilare tra due famiglie nobiliari che univano le proprie fortune per obbiettivi comuni.
Al matrimonio a Torino, avvenuto nel gennaio 1859, dopo una breve pausa di riflessione scoppiò la vittoriosa guerra contro l’Austria che però non portò, come era stato previsto, alla conquista di tutto il Centro Nord d’Italia; ne rimase fuori tutto il Veneto con Venezia, territorio che sarà poi conquistato nel 1866, 5 anni dopo la morte di Cavour.
Dopo la guerra del 1859, Cavour inviò Nigra come Ministro Residente a Parigi per proseguire l’attuazione degli accordi siglati con la Francia. Si occupò della cessione di Nizza e della Savoia alla Francia, che facevano parte del Trattato di Alleanza, ma poi si occupò dei rapporti con lo Stato Pontifico, protetto dalla Francia, che Garibaldi stava mettendo in pericolo con la sua impresa dei Mille, e che costrinsero Nigra a rientrare in Italia dove Cavour ne approfittò per inviarlo, ai primi del 1861, al seguito del Reggente delle Provincie Meridionali da poco annesse al Regno di Sardegna, Principe Eugenio di Carignano, come Segretario di Stato. Un incarico rilevante ma ricco di difficoltà per la situazione sociale del Sud, la poca volontà della popolazione locale a collaborare, gli interessi privati, la camorra ed il modus vivendi che i Borbone avevano instaurato, fatto sostanzialmente di benefici a molti in cambio di tranquillità sociale.
Furono mesi di duro lavoro in cui però Nigra seppe dimostrare doti di ottimo organizzatore avviando lavori pubblici, curando la riorganizzazione sociale, la costruzione di strade e ferrovie, la modernizzazione delle Scuole e degli Organi Istituzionali. I contrasti, le difficoltà socio-economiche, le difficoltà ad emettere norme e regolamenti per le tante opposizioni della popolazione e del clero, convinsero però il Principe di Carignano a rinunciare all’incarico e così, nel mese di maggio 1861, Nigra se ne tornò a Torino in tempo per dare l’addio al Conte di Cavour che il 6 maggio 1861, a causa di una malaria non diagnosticata e non curata, morì improvvisamente con il pensiero di non aver potuto vedere il suo sogno avverarsi.
Un lutto gravissimo per il paese e per tutti i suoi collaboratori che ne piansero amaramente la scomparsa.
Il Re Vittorio Emanuele II sostituì Cavour con il Conte Bettino Ricasoli e rinviò Nigra a Parigi, come Ministro Plenipotenziario del Regno d’Italia, a proseguire l’opera di mantenimento dei buoni rapporti con l’alleato più importante per il nostro paese, da lui iniziata.
Un incarico a cui erano affidate importanti questioni tra cui quella dei rapporti con lo Stato Pontificio che era diventato, come aveva affermato Cavour, “Libera Chiesa in libero Stato”, mediante la rinuncia ai beni temporali e cioè a tutti i possedimenti territoriali che il nuovo Regno d’Italia aveva sottratto alla Chiesa: Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Puglia.
Ministro a Parigi (1861-1876)
La sua permanenza a Parigi fu rivolta a risolvere i due impedimenti per l’unificazione dell’Italia: l’annessione del Veneto, ancora in mano all’Impero Austro-Ungarico, e l’annessione del Lazio e di Roma, ancora possedimenti dello Stato Pontificio.
Furono dieci anni di impegno politico per convincere Napoleone III, che non voleva più una guerra contro l’Austria per la conquista del Veneto e di Venezia, ad almeno non ostacolarne le operazioni che l’Italia avvierà poi con alleata la Prussia; e per convincerlo anche ad allentare la sua protezione, con l’avanposto francese di stanza a Civitavecchia, dello Stato Pontificio, lasciando il via libera all’ingresso dell’esercito italiano in Roma.
Il primo problema si risolse con la terza guerra di indipendenza del 1866 e l’intermediazione della Francia che consentì la ricongiunzione di Venezia all’Italia.
Il secondo problema occupò Nigra per tutto il decennio 1861-1870, con una inesauribile resistenza dell’Imperatore a proteggere la Chiesa, per il timore di perdere l’appoggio politico in Francia da parte del potente Clero francese. Nigra riuscì nel 1864 a far firmare al Governo francese (Convenzione di Settembre) l’impegno a gradualmente ritirare le proprie truppe da Civitavecchia in cambio del trasferimento della capitale d’Italia da Torino a Firenze, in vista poi del trasferimento definitivo a Roma; ma soltanto con la caduta dell’Impero francese, nel settembre del 1870, l’Italia poté occupare definitivamente Roma con il famoso episodio della –Breccia di Porta Pia – che la storia ricorda.
Il decennio parigino, sotto il secondo Impero di Napoleone III, fu per Nigra la consacrazione a rappresentante ufficiale del nuovo Regno d’Italia, proclamato ufficialmente il 17 marzo 1861.
La grande cultura, la preparazione politica, il savoir-faire, l’intelligenza, la stima di Napoleone III, dell’Imperatrice Eugenia e dei vari Ministri francesi, facevano di Nigra un diplomatico di grande valore, stimato (e temuto) dagli altri principali Ambasciatori europei: il prussiano conte di Goltz e l’austriaco Riccardo Metternich.
Riportiamo un giudizio su Costantino Nigra, scritto nel 1899 da Gustave Rothan (diplomatico e storico francese), nella prestigiosa Révue des Deux Mondes, parlando di Napoleone III e dell'Italia:
"Aveva iniziato il suo lavoro nell'ombra, a tutti sconosciuto prima d'apparire alla luce del sole. Il suo tatto, lo charme che emanava da lui, il suo sapere, la rettitudine e la prontezza dei suoi giudizi, condizionavano le scelte dei suoi superiori; le sue brillanti qualità gli avevano assicurato il favore inalterabile dell'Imperatore e dell'Imperatrice. A tutti i suoi meriti esteriori, fatti per piacere e per sedurre, Nigra aggiungeva l'arte della parola e riusciva a ottenere confidenze senza confidare i propri segreti.
Venne accreditato ufficialmente alle Tuileries e familiarmente a Palazzo Reale, ove le intese erano raramente d'accordo; veniva coinvolto negli affari di Stato più delicati nei momenti maggiormente critici.
Impegnato talvolta a dover interpretare una politica fatta di reticenze, aveva avuto dalla sua parte la fortuna - o la sorprendente abilità - di sapere come non compromettersi mai.
La sua azione diplomatica è stata spesso messa in discussione dal patriottismo italiano, ma la sincerità delle sue simpatie personali nei confronti della Francia non è mai stata mai oggetto di discussione ".
Anche lo scrittore francese Pierre De Lano, nel suo volume - La court de Napoleon III - pubblicato nel 1892 da Victor-Havard, Éditeur-Parigi scrive di Nigra:
“Tre furono i diplomatici che caratterizzarono il periodo più importante del secondo impero: il principe austriaco Richard Metternich, l'italiano cavalier Nigra e il prussiano conte di Goltz.
Nigra fu uno degli uomini di Stato più rimarchevoli e l'italiano giustamente più rispettato. Fu il tipo perfetto di diplomatico che non aveva soltanto in mente, per esprimere le proprie idee e i propri piani, l'amabilità della sua professione, ma un'abilità consumata, un senso politico assoluto, la capacità divinatoria di uomini e cose che gli impedivano di commettere errori e che, secondo l'opinione di un ministro di Napoleone III, gli facevano intuire gli avvenimenti, come un cane da caccia che fiuta la preda. In questa luce Nigra fu nettamente superiore al principe Richard Metternich, suo fedele compagno alle Tuileries, e si può dire che lo superò in tutte le questioni inerenti la politica del secondo impero.
Come Metternich Nigra era istruito, studioso ed elegante. Come lui amava la vita mondana, a corte, un leader attratto da tutte le gioie. Ma a differenza di Metternich, che seguiva la politica dei sentimenti, al richiamo cavalleresco del suo cuore, Nigra, senza cessare di usare il suo grande fascino, restava in ogni circostanza padrone di se stesso, e non praticava che la politica del raziocinio. Nessuno meglio di lui sapeva sedurre con la parola, coi gesti o con le attenzioni; ma se era pronto ad accettare tutto da coloro che lo circondavano, era molto riservato, conteneva gli entusiasmi, e con una freddezza d'animo implacabile, non rivelando nulla dei suoi pensieri, sapeva analizzare profondamente i pro e i contro prima di prendere decisioni. Non siamo quì per analizzare se tale comportamento sia lodevole o biasimabile. Ma tutto era sempre fatto nell'interesse del proprio paese e non dobbiamo andare al di là dei risultati da lui ottenuti.
L'Imperatore conosceva bene Nigra, sapeva valutare il grado della sua forza e lo temeva. Sognava di opporgli un uomo capace di resistergli, di leggergli le intenzioni, di combatterlo, di vincerlo, ma non lo trovò mai e ciò fu una delle sue sfortune.
Della stessa età di Metternich, Nigra, quando comparve a corte, fece sensazione. Bel giovane cavaliere, facendo valere la sua cultura, calzando stivali alla moda per le battute di caccia a Compiégne, divenne anche il favorito dell'ambiente elegante delle Tuileries, si vide presto circondato da molte simpatie, e il suo difetto di pronuncia del francese, fu presto ricercato e indicato come una delle sue tante attrattive.
La situazione di Nigra, nella società parigina, fu comunque delicatissima all'inizio.
Lo si sapeva un nemico dichiarato del potere temporale del Papa, un convinto assertore di Roma capitale d'Italia, e i salotti si irrigidivano quando vi entrava.
Il suo ruolo politico iniziò presto e non fu solamente il segretario di Cavour, ma il suo allievo preferito, il suo più stretto collaboratore. Prese parte attiva alle negoziazioni che precedettero e prepararono la guerra d'Italia e, a quell'epoca, l'Imperatore, che non aveva ancora avuto l'opportunità di conoscerlo da vicino, gli affidò diverse missioni che lui seppe portare a termine con molta capacità e successo. Il Re Vittorio Emanuele II lo aveva in grande affezione e stima. Dopo Cavour lo considerava come il suo più devoto aiutante, il più docile alle sue idee.
Grande rilevanza politica aveva, nella corte francese, l’Imperatrice Eugenia.
Il principe di Metternich era fortemente attratto dall'Imperatrice Eugenia; anche Nigra aveva per Lei uguale passione, o piuttosto, se Metternich ebbe sentimenti sinceri, Nigra, padrone dei propri sensi, fingeva per la sovrana una tenerezza che non fu mai, in realtà, nel fondo del suo cuore. E' questo un punto della storia assai delicato ma che non possiamo ignorare. L'Imperatrice era più sensibile agli omaggi del Nigra che a quelli del suo rivale; Lei lo ascoltava di più e tutti i consigli che Lei dava a Napoleone III erano sempre a sfavore dell'Austria. Non si può pretendere che si metta maggior tatto nel raccontare le indiscrezioni delle Tuileries aggiungendo pagine rosa a quelle della politica. Al di fuori di questa psicologia intima, l'Imperatrice Eugenia teneva molto a conquistare il Nigra, ad assicurarsene la benevolenza, sperando forse di ridurre la sua ostilità verso il papato allontanandogli il disegno di smembramento che lui portava e che da Lei era temuto; a questo riguardo l'aiuto di Metternich e della corte di Vienna Le era garantito. Nigra, che non si lasciava mai prendere in trappola, si manteneva in una sorta di attesa, di esitazione rispettosa che consentiva di "sperare quando si temeva il peggio". Questo particolare ci svela la sua abilità.
Quanto all'Imperatore, che, prodigando a Nigra ogni tipo di gentilezza, si fidava di lui, era stato ridotto dall'ambasciatore a discutere, giustamente, di quel comportamento attendista che, malgrado tutto, gli guadagnava il fondamento di tutte le simpatie che il sovrano gli riservava. Dopo la battaglia di Sadowa (persa dalla Francia contro la Prussia) Nigra capì che il ruolo di Napoleone III era, se non finito, grandemente sminuito in Europa, al presente come in futuro, e lavorò per ridurne le influenze negli affari d'Italia. Fu anche questo un vantaggio per rafforzare ancor più l'amicizia tra Nigra e Metternich.
Nigra, come già detto, è uno degli ultimi rappresentanti di quella diplomazia che ha illuminato il mondo, quasi come l'eco di una leggenda. Dopo il 1870 si è continuato a parlare di lui ed è rimasto come uno degli uomini di Stato più rimarchevoli di tutta Europa. Alla corte delle Tuileries fu come un Don Juan o un Macchiavelli, sorrise alle belle di corte, e alla politica, conquistandoli senza mai inorgoglirsi, e non facendosi mai sconfiggere nè dalle une nè dall'altra.
Dobbiamo invidiare la sua fortuna e non ignorarla”.
Ambasciatore d’Italia in Russia e Regno Unito (1876-1885)
La fama del Nigra e la sua reputazione gli aprirono tutte le importanti porte diplomatiche delle Grandi Potenze Europee.
In Russia (1876-1882) ebbe qualche momento di tregua nelle attività diplomatiche ed ebbe la possibilità di introdurre la cultura letteraria italiana, dopo i successi che gli architetti e gli artisti italiani (pittori e scultori) si erano guadagnati a San Pietroburgo, città nuova, con all’interno quello straordinario Museo, di fama mondiale, che è l’Hermitage. Quest’uomo di cultura era ambito in tutte le serate delle famiglie nobiliari in cui parlava non soltanto di politica ma anche di poesia, di letteratura, di pittura e scultura: un uomo dalla preparazione e dalla dialettica unica che incantava gli interlocutori con il suo francese dall’accento piemontese e con il suo garbo educato e gentile. Sei anni spesi a divulgare l’italianità, a frequentare la nobiltà, a cacciare orsi e cervi, a presenziare a grandi cerimonie e feste di corte.
Poi il neo Re Umberto I lo vuole nella capitale che conta, Londra, ove la prima potenza mondiale si appresta a varare il primo e più grande progetto ingegneristico dei tempi: il Canale di Suez. Naturalmente la sua fama lo vuole come membro del Comitato Internazionale che ne regolerà l’utilizzo a livello mondiale.
E Umberto I vuole che vi figuri come nobile, alla stregua di tutti gli altri membri, e gli conferisce, per i suoi meriti pregressi, il Titolo di Conte !
Un semplice giovane di uno sperduto paese del Canavese assurge, nel 1883, ad un primo scalino nobiliare che sarà poi seguito da altri importanti tra cui, negli anni ’90, il conferimento del Collare della S.S. Annunziata (con cui diventa cugino del RE) e subito dopo la nomina a senatore del Regno d’Italia.
La permanenza in Inghilterra gli riserverà un riconoscimento importante, quello della laurea Honoris Causa dell’Università di Edinburgo (in occasione del bicentenario di fondazione), per i suoi meriti di studioso della Canzone Popolare Italiana (di cui rimane ancora oggi un precursore riconosciuto) ma anche quello di aver modificato radicalmente i rapporti con il Foreign Office, introducendo l’italiano come lingua di comunicazione.
Ma la sua consacrazione di Ambasciatore Decano della Diplomazia Europea avviene nel 1885 con il suo trasferimento nella capitale della Diplomazia: Vienna.
Ambasciatore a Vienna (1885-1904)
Vi giunge preceduto dalla fama di Grande Ambasciatore, di uomo colto, dalla acuta intelligenza politica, dallo charme nei confronti di uomini e donne, dal piacevole conversare.
A fine ottobre 1885 il neo Ministro degli Esteri, generale Robilant, faceva pervenire a Nigra questa lettera: “Caro Nigra, il giorno stesso in cui accettai il portafoglio degli Affari Esteri, mi preoccupai immediatamente della nomina del mio Ambasciatore a Vienna, sede che avevo occupato sino ad allora e che, con la mia nomina a Ministro, lasciavo vacante. Feci oggetto di attento esame il ruolo del nostro alto personale diplomatico, studiai le varie candidature possibili fra gli uomini politici, ed il risultato di tutto quel lavoro mentale fu quello di convincermi che la persona più conveniente, più appropriata per quel posto nelle attuali gravi condizioni, siete Voi caro Conte. In tal senso sto per avanzare la mia regolare proposta a Sua Maestà; prima però mi piacerebbe ricevere da Voi la conferma che di buon grado accettate quel trasferimento o che almeno, nell’interesse del Re e dell’Italia, vi piegate, con la voluta rassegnazione, ad obbedire al vostro destino. Supposto che si tratti di grave sacrificio per Voi, mi permetto pregarvi di osservare che ho qualche diritto di chiedere ad altri un sacrificio e mi sia lecito aggiungere che, da quanto intesi da Sua maestà, tale diritto mi spetterebbe ancora di più nei vostri riguardi! Facendo però astrazione da ogni altra considerazione, mi lusingo pensare che accetterete di buon grado, animato dal convincimento che in quel nuovo vostro posto avrete occasione di rendere, nelle presenti contingenze, indubbi servigi al paese. L’elettissimo vostro ingegno, la grande esperienza, l’abilità diplomatica e la fermezza all’occorrenza, sono eminenti qualità che possedete in sommo grado e che tutti in Italia ed all’Estero vi riconoscono. Ai miei occhi nessuno è dotato, in più alto grado di Voi, di tutte quelle qualità che, nelle presenti circostanze ed in altre non lontane a verificarsi, reputo indispensabili a chi deve andare a rappresentare l’Italia a Vienna, nella nuova fase in cui siamo entrati. Altro non aggiungo perché sarebbe superfluo, con un uomo di mente sì elevata, quale è la vostra, e di tanta provata devozione alla Dinastia ed al Paese. Aspetto la Vostra risposta con piena fiducia ”.
La sede prestigiosa, l’incarico importante, la rinnovata fiducia da parte del Governo e del Re costituivano un richiamo forte a cui Nigra non poteva opporsi.
Dopo la sua accettazione il Re in persona, il 1° novembre, gli scrisse:
“Nell’apprendere la scelta, non tardo ad esprimervi, caro Conte, tutta la mia soddisfazione ed i miei ringraziamenti per questa nuova prova del vostro patriottismo e della vostra devozione e vi assicuro che, oltre ai vostri buoni servizi, apprezzo altamente, soprattutto in queste circostanze, la vostra nobilissima condotta ”.
Qualche giorno dopo il ministro Robilant gli comunicava che anche l’Imperatore Francesco Giuseppe, il rivale delle tante lotte italiane per l’indipendenza, accettava con piacere la nomina che giungeva, ufficialmente, con regio decreto del 10 novembre 1885.
La permanenza a Vienna fu il giusto riconoscimento di una carriera esemplare, non solo professionalmente, ma come sigillo di una vita di impareggiabile al servizio al paese.
Iniziava la fase della maturità, in cui Nigra poteva dedicarsi alle attività diplomatiche con la tranquillità dell’esperienza e senza affanni, ed anche alle attività culturali, per le quali sentiva ancora di poter dare un contributo importante.
Erano tempi quelli in cui le casate dai nomi altisonanti non avevano ancora ceduto le loro fastose ricchezze alle classi borghesi e segnatamente a quelle israelite, e continuavano ad esercitare, insieme a quella mondana, una funzione politica ponte, tra la tendenza regionalista e l’accentramento imperiale metropolitano. A questi l’Imperatore Giuseppe II, non volendo lasciar decadere gli antichi diritti aristocratici e investendoli anzi di nuovi diplomi e privilegi, aveva loro imposto di svernare a Vienna in palazzi di loro proprietà. Alcune famiglie poi godevano di un autentico potere rappresentativo, come i principi di Fűrstenberg che, sedendo per diritto di nascita in quattro senati diversi, Vienna, Berlino, Stoccarda e Baden, erano divenuti gli intermediari confidenziali fra il Kaiser di Germania e l’Imperatore d’Austria.
Francesco Giuseppe aveva un’ anima burocratica che sentiva impregnata di crisma divino e che non ammetteva potesse venir sfiorata da critiche e da obiezioni. Esigeva, da tutti coloro che lo circondavano, le virtù del soldato e del gentiluomo e rispettava anche il nemico più acerrimo, purché si comportasse con onestà e correttezza. Questo spiegava l’alta considerazione avuta nei confronti di tutti gli ambasciatori italiani che avevano preceduto Nigra e che ora riservava a lui; Nigra aveva in più un merito, quello di essersi conquistato la popolarità che avevano avuto i grandi ambasciatori delle grandi potenze, pur essendo ambasciatore di un piccolo Stato che Nigra aveva contribuito a far diventare una nuova grande potenza.
In queste manifestazioni di ammirazione, però, Francesco Giuseppe non tradiva mai il suo burocratico rispetto per ogni tipo di protocollo.
Quando Nigra fu ricevuto, insieme al corpo diplomatico accreditato a Vienna, per gli auguri del Capodanno 1886, com’era tradizione, egli iniziò la conversazione col decano dei diplomatici, il Nunzio Apostolico del Papa, discorrendo in lingua italiana; ma appena fu vicino a Nigra ricorse immediatamente alla lingua diplomatica, quella francese, a sottolineare la diversa considerazione delle due ambascerie che giungevano da Roma.
La sede della ambasciata italiana a Vienna era situata a palazzo Pallfy, in Josefplatz 1, di fianco al palazzo Pallavicini; l’edificio, concepito come un blocco squadrato a pianta rettangolare, si ispirava, nella sua solenne ed austera monumentalità, al palazzo Farnese di Roma, pur nella diversità delle proporzioni e della scansione dei piani; la facciata presentava due ordini di finestre su quindici assi ed era coronata da un poderoso cornicione a dentelli; sul livello stradale il palazzo era difeso da una piccola barriera consistente in pilastri di pietra uniti da pesanti catene in ferro che certificavano il diritto di catena risalente al medioevo, e indicante la linea di divisione tra l’alta aristocrazia e la borghesia.
Per apprezzare questo angolo della vecchia Vienna occorreva attendere la sera quando lungo il corridoio della Augustinerstrasse, la Josefplatz ed il porticato della Scuola d’Alta Equitazione spagnola, fossero calate nel silenzio in cui, col tramonto, quei metropolitani provinciali, che sono i viennesi, abbandonano il monumento.
L’Ambasciata italiana si era guadagnata, sin dal 1866, grande reputazione e aveva creato le premesse per favorire l’autorevolezza che il conte di Robilant aveva saputo guadagnarsi; una diritta nobiltà di carattere che appariva già in quella figura di vecchio soldato che aveva lasciato un braccio sui campi di battaglia del 1848, e che era stato, da questo punto di vista, tenuto in gran conto dall’Imperatore, così sensibile alle virtù guerresche.
Diversa era la considerazione che l’Imperatore riservava a Nigra: la sua intima collaborazione al processo unitario, il pennacchio da bersagliere che aveva coperto la sua fronte nella guerra del 1848, l’aureola di poeta e studioso di letteratura ed arte, il fascino che sapeva esercitare sulle dame di corte; queste erano le doti che lo avevano fatto apprezzare da lui insieme ad una rigorosa dirittura morale che lo aveva fatto stimare nel mondo della diplomazia europea.
A fine gennaio 1889 un avvenimento tragico turbò gravemente il clima di corte ed impressionò l’opinione pubblica di tutti i paesi; il principe ereditario d’Austria Ungheria, Rodolfo, figlio primogenito di Francesco Giuseppe, veniva trovato morto, insieme alla sua amante, la baronessina Maria Vétzera, nella stanza da letto del suo castello di caccia a Meyerling. Si parlò di assassinio e di doppio suicidio, ma nessuno potè mai capire la dinamica dell’incidente; l’unica cosa chiara era il fatto che il principe era in contrasto continuo con la moglie Stefania, con la quale aveva frequenti scene di gelosia dovute all’indole donnaiola di Rodolfo, di cui tutta Vienna parlava.
Il periodo viennese fu ricco di preoccupazioni per l’evolversi della situazione europea.
Da un lato la Francia che, anche a causa della Triplice Alleanza e dei suoi rinnovi, continuava a manifestarci ostilità in conseguenza della rottura delle relazioni commerciali avvenuta anni prima; gli eccidi di operai italiani ad Aigues Mortes, i cui responsabili erano stati assolti dalla corte francese di Angoulême; la contrapposizione militare tra Francia ed Italia in Abissinia. Dall’altro lato, il cattivo trattamento riservato dal governo austriaco agli italiani residenti in Austria; questo era dovuto al fatto che gli italiani volevano mantenere una propria identità, linguistica e nazionale, mentre il governo cercava una integrazione di tutte le etnie soggette. Nel panorama politico l’alleanza Franco Russa del 1891 ridava ai francesi nuovo vigore politico con speranze revansciste ed ai russi la tranquillità di poter portare avanti la politica espansionistica nei Balcani, in contrapposizione a Vienna.
Germania ed Austria erano, all’inizio del 1894, impegnate ad un riassetto politico e l’Austria anche per mantenere tranquille le popolazioni dell’Ungheria, che davano segni di irredentismo. Noi italiani a Vienna dovevamo accettare una situazione di sudditanza poco decorosa, imposta dalla Chiesa austriaca, appoggiata dalla casa imperiale, che ci accusava di aver usurpato il potere temporale del Papa, tanto da impedirci di esporre pubblicamente il tricolore in occasione della festività nazionale del XX settembre; era una politica antiitaliana che dall’Austria veniva portata avanti in Dalmazia, nell’Istria, a Trieste e nel Friuli orientale, ancora sotto la dominazione austriaca.
Ma queste preoccupazioni si attenuavano quando Nigra si dedicava, nel tempo libero, allo studio della letteratura italiana, in quei tempi molto fiorente; Giovanni Pascoli, allievo di Giosué Carducci, era il poeta emergente che aveva chiesto a Nigra un parere poetico sulla terza edizione delle Myricae, a cui aveva risposto con queste profonde osservazioni, che ci fanno capire la profondità di cultura poetica del Nigra:
“Avevo già letto, con simpatica ammirazione, la più parte di queste Myricae, sbocciate, direi, nelle più olezzanti aiuole delle Esperidi, se in quegli orti, insieme alla luce limpida dei cieli, piovessero anche le lacrime umane. Un sentimento vero, profondo, proprio provato nelle viscere; l’amore e la visione esatta della natura agreste; l’alata fantasia che, come raggio di sole, vivifica tutto quello su cui cade un filo d’erba selvaggia; costituiscono, mi pare, il carattere geniale di questa nuova poesia; dico nuova perché un tal genere di lirica è nata da non molto tempo in Italia ed il Pascoli d’un tratto si alzò fra i maestri”.
Sul finire del secolo le relazioni tra Austria ed Italia, pian piano migliorarono.
Gli ottimi rapporti di Nigra con l’Imperatore, ed una nuova fase di politica estera avviata dal ministro Emilio Visconti Venosta, ci consentirono di superare gradualmente le rivalità e gli odi nazionalistici per ripristinare buoni rapporti con l’Austria e la Francia prima, cordiali rapporti con la Russia ed i Paesi dell’Est poi, culminati nel matrimonio del figlio ereditario di Umberto I, Vittorio Emanuele, con la principessa Elena di Montenegro, che portò legami parentali tra le due monarchie. Di questo matrimonio Nigra ebbe, su richiesta del Re Umberto, ad occuparsi, in quanto da lui incaricato di accertare, con il dovuto tatto, se i genitori della principessa Elena erano favorevoli alla eventuale unione della loro figlia con Vittorio Emanuele; missione che Nigra portò a termine felicemente.
Ai primi di giugno del 1892 una bella notizia raggiunse Nigra: Re Umberto lo nominava Grande Ufficiale dello Stato, insignendolo del Collare della S.S. Annunziata; il riconoscimento più importante mai concessogli, con cui entrava a far parte della famiglia reale, come cugino aggiunto; la sua ascesa ai vertici gentilizi aveva raggiunto la vetta.
Non mancarono però altri motivi di grave preoccupazione. Nel settembre 1898 l’Imperatrice d’Austria Elisabetta, la celebre Sissi, fu uccisa in un attentato, a Ginevra, per mano di un anarchico italiano, certo Luigi Luccheni, che le inferse una pugnalata mortale mentre l’Imperatrice si avviava ad imbarcarsi su di un battello nel lago Lemano. Nigra portò all’Imperatore le condoglianze della Famiglia Savoia e di tutto il Paese che Francesco Giuseppe accettò.
Altri problemi nascevano in tutta la penisola balcanica dove moti insurrezionali e malgoverni locali impensierivano Francesco Giuseppe, che aderì per primo all’appello dello Czar Nicola II Romanoff, succeduto ad Alessandro III, per una conferenza rivolta a favorire il mantenimento della pace ed il disarmo, conferenza che fu fissata all’Aia per il luglio 1899 ed alla quale aderirono ben 26 paesi tra cui l’Italia, che delegò Nigra come suo Capo Delegazione. Fu quella l’occasione per il riconoscimento ufficiale del Nigra a livello europeo in quanto fu nominato Capo del Comitato di Redazione dei Lavori durati alcuni mesi.
In quella Conferenza accadde un fatto mai verificatosi in precedenza nelle riunioni diplomatiche; in queste si usava, per consenso e comodità di tutti, la lingua francese. Però un giorno, in una delle pubbliche sedute, il Plenipotenziario americano prese la parola in inglese. Subito dopo, venuto il turno del rappresentante germanico, questi parlò in tedesco; allora Nigra si alzò e si mise a parlare nella lingua di Dante; l’Assemblea applaudì fragorosamente!
All’inizio del nuovo secolo Nigra avvertì che era giunta l’ora del suo ritiro; dopo oltre 50 anni di intensa attività al servizio del proprio paese, di grandi tensioni e di ininterrotta opera per difendere gli interessi dell’Italia in tutti i grandi contesti internazionali, Nigra chiese al Ministro di potersi ritirare in congedo definitivo, ma la cosa fu rinviata a dopo le trattative del rinnovo della Triplice Alleanza che furono discusse nel 1902. Esemplare lo stile epistolare esemplare del Nigra che al Ministro degli Esteri Prinetti scriveva:
“Il Corriere è finalmente giunto oggi da Berlino, e lo faccio proseguire senza ritardo per Udine. Nella spedizione Ella troverà il rapporto col quale La informo che ho letto al Ministro degli esteri austriaco Goluchowski la memoria contenente le dichiarazioni convenute per la firma della proroga dell'alleanza. Goluchowski constatò che quelle dichiarazioni erano conformi a quelle fattele in di lui nome da Pasetti. Debbo dirle, a questo riguardo, che quando Io gli lessi la memoria, Goluchowski mostrò un po' di sorpresa, osservando che quelle dichiarazioni Le erano state fatte da Pasetti in di lui nome e che non c'era quindi luogo a confermarle. Ma Io gli dissi che, a dire il vero, non ero stato incaricato di fargli una nuova comunicazione al riguardo, ma soltanto di constatare con lui l'esattezza delle scritture. Ella troverà pure nella spedizione alcune osservazioni circa i rapporti dei nostri consoli a Scutari e Durazzo. Io credo che quei bravi Signori si lascian vendere lucciole per lanterne dai dragomanni e da basse spie che tirano partito dalla loro credulità. Io posso credere fino ad un certo punto che i Consoli austriaci rispondono ai nostri tentativi di propaganda italiana, proclamata con soverchio chiasso dai nostri albanofili, con eguali ed anche maggiori sforzi di propaganda austriaca. Trovo naturale che l'Austria tenti dal suo lato una propaganda di difesa, come rispose tempo fa con una dimostrazione navale austro-ungarica alla corsa dei nostri navigli da guerra sulla costa Albanese. Ma che tenti di corrompere la guarnigione turca, sopratutto nel modo descritto dai nostri Consoli, non lo credo. Ad ogni modo Io penso ch'Ella deve esigere dai nostri Consoli d'informarla delle sorgenti a cui attingono le loro notizie, e non deve accontentarsi di allegazioni, così strane, senza prove. Io sventuratamente non ho mezzo di controllare quì quelle dicerie. A Goluchowski posso dire anche le cose più delicate senza inconveniente. Ma veramente se Io gli domandassi se ha autorizzato il Console Austro-Ungarico a Durazzo di trasmettere a quel famoso Dervisch Bey una sua carta da visita, egli potrebbe pensare che son minacciato d'una incipiente idiozia. Ella ha ragione di constatare con qualche soddisfazione il risultato dell'opera sua, cioè il rinnovamento dell'alleanza senza aver destato il malumore della Francia. È un gran servizio ch'Ella ha reso, come ben dice, all'Italia, alla Monarchia, ed alla Triplice Alleanza, e si può aggiungere alla Pace di Europa. Nessuno più di me La applaude e La felicita”.
Il grande ambasciatore se ne va in pensione a fine 1904 e saluta il Ministro degli Esteri Tittoni con questa lettera:
Venezia, San Simeon Grande - 27 novembre 1904
“Signor Ministro, mi pregio di segnar ricevimento e ringrazio Vostra Eccellenza della copia del R. Decreto che mi colloca a riposo in seguito a mia domanda, e Le sono sopratutto riconoscente per la lettera con cui Ella volle accompagnarne l'invio. Questa sua lettera è per me una nobile testimonianza di buon servizio ed ho caro che mi venga da Lei. La risoluzione di ritirarmi a riposo fu dettata, com'Ella sa, dalla coscienza che ho di non posseder più, per età e salute, la forza di lavoro necessaria per l'alto ufficio che mi era affidato. Non la presi con cuor leggero, nè senza tristezza. Ma non la rimpiango, convinto come sono d'avere costantemente compito un dovere. Dolente di rinunciare così a prestare a Lei la mia collaborazione sono però lieto di vedere che la direzione della politica estera dell'Italia è in buone mani, e fo plauso sincero ai primi successi di V.S. che auguro e spero siano continuati in avvenire. Voglia gradire, La prego, l'espressione della mia profonda osservanza. Nigra”
Un grande Ambasciatore quindi, un Grande Italiano certamente, un Grande canavesano che ha saputo percorrere tutti gli scalini della storia del nostro Risorgimento, rivestendo ruoli fondamentali con una capacità intellettuale degna di essere riconosciuto come “uno dei protagonisti del processo di unificazione dell’Italia”. La diplomazia italiana gli ha riconosciuto questi meriti che la storia non gli ha attribuito, dimenticandolo completamente ed ingiustamente da ogni significativa citazione.
E’ compito di noi canavesani quello di saper rivalutare la figura di questo nostro conterraneo per ridargli quella dignità patriottica che merita e che la storiografia ufficiale non gli ha riconcosciuto.
2° articolo: Costantino Nigra: studioso della canzone popolare piemontese
Introduzione
Nigra è assai noto per la sua pubblicazione “I Canti popolari del Piemonte”, che rappresenta un’opera fondamentale nel campo della etnologia e del folklore italiano.
Come afferma Giuseppe Cocchiara, antropologo ed etnologo italiano, fra i maggiori studiosi di storia delle tradizioni popolari e folklore, i Canti popolari del Piemonte costituiscono una delle opere più valide della filologia folcloristica del secolo scorso. Editi nel 1888, essi sono il frutto di un'opera vigile e coscienziosa iniziata fin dal 1854, nell'epoca, cioè, in cui il Nigra cominciò a pubblicare su alcune riviste italiane e straniere — « Il Cimento », « La Rivista Contemporanea », « Romania », ecc. una serie di canzoni popolari che non solo rivelarono un nuovo filone della poesia popolare italiana, ma impegnarono il raccoglitore a delineare una nuova metodologia nella raccolta e trascrizione del materiale.
I Canti popolari del Piemonte, nei quali il Nigra utilizzò i materiali già raccolti e rielaborò i risultati cui era giunto, non sono infatti soltanto un'opera di filologia, ma un saggio di storia della poesia popolare, o meglio, un quadro storico-filologico, non certo privo di qualche ombra, ma certamente ricco di scorci che continuano a conferire all'insieme vita e calore.
Si può anzi affermare che i Canti popolari del Piemonte, con la relativa problematica che li anima, sono stati e restano tuttora il banco di prova dei maggiori folcloristi italiani, ai quali il Nigra ha aperto una nuova provincia del sapere.
Il volume include i canti raccolti, in vari tempi e in quasi ogni parte del Piemonte, da Nigra e da moltissimi suoi collaboratori. Il maggior spazio del libro è preso dalle canzoni d'indole profana che, per la materia trattata, sono storiche, o romanzesche, o domestiche e amorose. Per agevolare la lettura dei testi piemontesi fu messa anche una traduzione italiana ed aggiunto anche un breve repertorio lessicale di quelle voci dialettali che più si scostano dalla forma italiana.
Il volume include Canti narrativi (153), Orazioni e giaculatorie religiose (6), Cantilene e rime infantili (11), Strambotti (183) e Stornelli (10). Sono pubblicati anche alcuni spartiti musicali di alcune canzoni.
Scrive su questi canti il celebre filologo francese Gaston Paris, nella sua pubblicazione su “Journal des Savants” del settembre-novembre 1889:
“Questo bel volume realizza un desiderio espresso già da tempo in molte lingue europee. Sin dal 1854 Nigra iniziò la raccolta e la pubblicazione di molte canzoni raccolte in Canavese ed in altre regioni del Piemonte. La bellezza di alcuni di questi canti, l’interesse che la maggior parte di essi rappresenta per gli studi comparativi, la precisione con cui l’autore li ha trascritti, ne fanno argomento di interesse per tutti coloro che si occupano degli studi della canzone popolare europea. Ma non è solamente l’interesse scientifico che attira l’attenzione sul lavoro del Nigra, ma soprattutto la fedeltà con cui trascrive e commenta questi canti, nonché l’eleganza della sua interpretazione”.
La Fondazione Enrico Eandi, data l’importanza dell’opera, ha deciso tempo fa di effettuare un’attività di digitalizzazione della prima edizione del 1888 dei Canti popolari del Piemonte, edita a Torino da Loescher, per renderli disponibili alla collettività per attività di studio, approfondimento o curiosità.
Il primo importante contributo esplicativo, su quest’opera, ci viene dal Nigra stesso che nella prefazione della prima pubblicazione, scrive:
“Sciolgo, in parte, una promessa da me fatta al pubblico da molti anni. La pubblicazione presente è più modesta di quella da me sperata e promessa. Ma ho stimato preferibile pubblicare la raccolta da me riunita di canti popolari piemontesi nello stato in cui si trova, anziché correre il rischio di non pubblicarla affatto, illudendo me stesso colla speranza, ormai vana, di renderla più completa di testi e di commenti.
Sono adunque qui pubblicati i canti popolari raccolti, in vari tempi, in quasi ogni parte del piemonte da me e dai miei antichi collaboratori. Il testo è stampato quale venne cantato o dettato a me, o quale fu trascritto dai miei colloaboratori dal canto o dalla dettatura. Non vi furono fatti cambiamenti al di fuori di quelli richiesti dall’ortografia e dalla punteggiatura, o da evidenti errori materiali dei trascrittori.
Il maggiore spazio del libro è preso dalle canzoni propriamente dette, d’indole profana. A queste canzoni furono unite alcune canzoni religiose. Segue poi un saggio di orazioni e giaculatorie religiose e uno di cantilene, di rime infantili e di giuochi.
La raccolta si chiude con una piccola raccolta di Strambotti e stornelli, nello scegliere i quali mi studiai di escludere quelli che fossero già stati pubblicati da altri.
Per agevolare la lettura dei testi piemontesi, la traduzione italiana fu messa di seguito, non di tutte, ma di una versione almeno di ogni componimento.
Alla fine del libro vi è un breve repertorio lessicale di quelle voci dialettali, usate nei testi, che più si scostano dalla forma italiana, accompagnate dalla rispettiva traduzione in italiano.
Precede la raccolta, a guisa d’introduzione, uno studio sulla poesia popolare italiana.
I componimenti pubblicati furono in parte raccolti da me stesso in Torino e sulla collina di Torino, e nella valle di Castellamonte in Canavese e trascritte dal canto o dalla dettatura, per lo più di contadine, che facevo ripetere due o tre volte e in epoche diverse. Fra queste cantatrici e dettatrici, devo citare in primo luogo una vecchia donna, ora defunta, Domenica Bracco, poi Teresa Croce e teresa bertino, tutte e tre della Valle di Castelnuovo nel circondario di Ivrea. Un’altra parte considerevole della collezione, mi fu trasmessa o rimessa da molti collaboratori, alcuni dei quali portano un nome ben noto in Italia. Giovanni Flechia, l’illustre professore di sanscrito nell’Università torinese, mi diede, fin dal 1853, una raccolta di canzoni da lui trascritte in Torino sotto la dettatura di Giuseppina Morra-Fassetti.
Domenico Carbone, già mio compagno di studi e d’armi, mi diede3 nel 1858, le canzoni da lui raccolte nel suo nativo villaggio di carbonara presso Tortona. Domenico Buffa, noto nella storia politica del nostro paese, mi fece dono nel 1858 del suo manoscritto di canti popolari piemontesi e liguri da lui raccolti, dal 1842 al 1845.
Parenti, amici e colleghi trascrissero per me molte canzoni in varie parti del Piemonte, nel Monferrato, in Bra, a Mondovì e Pinerolo, in Graglia vicino a Biella, a Lanzo torinese, in Montaldo di Mondovì, a Novara, Saluzzo, Benevagienna e ancora in Paesana, Lagnasco e Val di Po circondario di Saluzzo, in Rocca d’Arazzo circondario di Asti. Finalmente due buone collezioni mi vennero trascritte in Valfenera d’Asti e ad Alba, e ancora altre vicino a Parma, a Venezia, nel Vicentino e vicino a Pisa.
Tutti i raccoglitori di canti e di racconti popolari sanno quanto sia arduo questo mestiere ma a loro va il ringraziamento per il prezioso lavoro svolto.
A questi tenaci custodi del nostro canto popolare ben si può applicare il bel detto del Conde Arnaldos, il Conte spagnolo Arnaldo grande scrittore di ballate, con cui amo chiudere questa prefazione:
- Yo no digo esta cancio sino a quien conmigo va
- Non canto questa canzone se qualcuno non mi accompagna”
Valore europeo de “I Canti popolari del Piemonte” (di Emilio Jona, Franco Castelli, Alberto Lovatto)
Per comprendere appieno il ruolo di innovazione e di rottura che Nigra riveste nel panorama degli studi demologici italiani dell'Ottocento, basterà constatare come la sua scelta del genere narrativo e la sua metodologia di ricostruzione filologica e storica della vicenda di ogni singolo canto, si ponga decisamente controcorrente rispetto al prevalente indirizzo di stampo letterario e linguistico, avviato in Toscana dalle raccolte di Niccolò Tommaseo (1841-42) e di Giuseppe Tigri (1856).
Nei folkloristi romantici la mitizzazione poetica dell' ”anima popolare” conduceva a cercare nelle canzoni del popolo “l'arcana sapienza antica (...) espressa in concetti imaginosi”, perdendo di vista il reale contesto socioculturale delle classi portatrici di cultura folklorica.
Questa decontestualizzazione, che portava a fingere “un popolo di fantasia che poco ha da fare colla realtà”, aveva indotto un acuto critico militante di scuola cattaneiana, come Carlo Tenca, a scendere in campo sulle colonne de “Il Crepuscolo”, nel 1857, per additare come nello studio della poesia popolare, anzi, dei canti popolari toscani (così si intitola l'articolo) altri modi di indagine fossero possibili, esterni e diversi dagli sdilinquimenti sulle “incorrotte avene” e sui puri fiori di favella toscana.
Tenca sosteneva lucidamente l'importanza di assumere i canti popolari come documenti per “una storia delle contadinanze italiane” e “delle plebi cittadine” e, contro la prevalente idillizzazione, sottolineava l'importanza di indagare, nel patrimonio del canto popolare, quegli aspetti in grado di testimoniare la vita reale delle classi subalterne, primo fra tutti il concetto di lavoro, “che appare terribile e doloroso nei canti toscani, in quella migrazione dei contadini per la Maremma”.
Ma non è che Nigra fosse estraneo alla cultura romantica, anzi, come bene ha scritto lo storico Federico Chabod:
“Costantino Nigra era originariamente, di animo e d'intelligenza, come uomo e come poeta, un romantico; nel mondo romantico era rimasto come araldo diplomatico del principio di nazionalità, incarnando ben una generazione che non aveva più la mentalità raziocinante e matematica del '700, e non ancora la mentalità positivistica della fine dell' '800. Lo stesso abbandonarsi alla fievole ma decorosa vena poetica, la sincerità e ricchezza degli interessi culturali, il culto amoroso delle tradizioni popolari, eran tutti elementi che legavano il Nigra all'età romantica”.
Come avviene dunque, in Nigra, questo superamento, nello studio dei canti popolari, di una tendenza generalizzata alle valutazioni approssimative e agli abbandoni sentimentali, a favore di un metodico e scrupoloso lavoro di ricostruzione filologica e storica della vicenda di tipi, di forme, di generi, di testi? Cosa lo porta, pur senza perdere l'aggancio ai valori positivi del popolarismo romantico, a differenziarsi nettamente, riconoscendo che l'unica forma possibile di giudizi e di interessi era quella della comparazione a vasto raggio, su base etnolinguistica?
Nel Centro Studi Costantino Nigra di Castellamonte, i ritagli di articoli dell'anno 1888 e seguenti, che danno conto dell'eco europea della pubblicazione dei Canti, sono senz'altro illuminanti, così come le tracce epistolografiche dei contatti nigriani con studiosi europei come Alfred Jeanroy, Gaston Paris, Damase Arbaud, J. Fleury, Svend Grundvigt, ecc.
Purtroppo la dispersione delle carte di Nigra non ci consente di avere un quadro preciso della fittissima sua corrispondenza con i maggiori studiosi europei impegnati sul versante della filologia e degli studi di poesia popolare. Siamo dunque costretti a compiere una ricognizione indiretta e congetturale, avvalendoci del “paradigma indiziario” teorizzato dallo storico Carlo Ginzburg in suo noto saggio.
Le undici pagine di “Opere citate” (come viene definita la bibliografia sterminata apposta da Nigra in fondo alla sua raccolta), sono il segnale eloquente della sua radicale difformità rispetto al lavoro degli altri raccoglitori nostrani di canti popolari. Già Cocchiara , del resto, nella sua prefazione del 1957, scriveva che Nigra: “favorito dalla sua fama in campo diplomatico, accostò i maggiori folkloristi europei, francesi, austriaci, inglesi, tedeschi, svedesi, russi, ecc. Dal Paris al Child, non vi fu infatti folklorista straniero che egli non conoscesse e con il quale non fosse in corrispondenza”.
Certamente, questo sguardo largo, internazionale, venne favorito dal ruolo politico che Nigra, stretto collaboratore di Cavour, esercitò come ambasciatore in alcune delle più importanti capitali europee (nell'ordine, Parigi, San Pietroburgo, Londra, Vienna), ma questo non sarebbe bastato, senza le doti precipue dell'intellettuale e dello studioso.
Dobbiamo riconoscere come da noi, in Italia, si sia ancora piuttosto carenti di informazioni relative a studi e ricerche sulla ballata europea, nonché sugli studi di filologia folklorica extraitaliani, per cui qui basti segnalare alcune semplici date indicative del vasto processo elaborativo degli studi internazionali sul canto e sulla tradizione orale, che Nigra seguiva con attenzione.
Oltre all'amico filologo e medievista Gaston Paris (1839-1903), certamente occorre menzionare due altri nomi di filologi raccoglitori di canti, quasi coetanei, con i quali Nigra dovette intessere un fecondo confronto scientifico: il danese Svend Grundvigt (1824-1883) che fu il vero iniziatore del metodo comparativo, e Francis James Child (Boston 1825-1896) statunitense infaticabile indagatore, i cui cinque volumi delle English and Scottish Popular Ballads, dovevano essere ben noti al nostro.
Se con l'amico Alessandro D'Ancona, filologo italianista, può confrontare la tradizione di canto piemontese con la tradizione toscana, con questi “compagni di strada”, Nigra imbocca decisamente la strada della filologia folklorica, il che significa passare dalla letteratura alla scienza, fondata sui principi dell'etnografia, della linguistica, della dialettologia e della comparazione internazionale. Il che significa, in sostanza, rigore nella trascrizione dei testi, nella registrazione delle fonti, nell'analisi comparata delle varianti, pur senza tradire l'eredità romantica.
Il PENSIERO di Alberto Mario Cirese, decano degli etnologi italiani, sull’opera del Nigra
Introduzione al volume de „I Canti popolari del Piemonte“ a cura di Emilio Jona, Franco Castelli e Alberto Lovatto edito da Giulio Einaudi – Torino 2009
Nelle varie attività di Costantino Nigra, le ricerche sulla poesia popolare occupano un posto essenziale sia per la continuità dell’impegno sia per la qualità dei risultati. Nigra le avviò nel 1854 con uno scritto dal titolo „I canti popolari del Piemonte“ , le sviluppò con le „Canzoni popolari del Piemonte“ nel 1855-56, la „Poesia popolare italiana“ del 1876, le ricapitolò e le coronò con il volume fondamentale del 1888 intitolato anch’esso „I Canti popolari del Piemonte“.
Il prevalente riferimento dei titoli ai fatti piemontesi non deve trarre in inganno. Se la materia su cui si esercita lo studio è (all’origine) regionale, i problemi, il tipo di riflessione e il metodo sono di raggio e di livello europei, sia per la robusta solidità dell’impegno del Nigra, sia per i documenti cui egli lo applica, e cioé le canzoni piemontesi che già di per sé sono una provincia del vastissimo territorio culturale che va dalle ballate anglo-scozzesi o germaniche alle chansons francesi, ai romances spagnoli ecc.
Del resto il saggio su „La poesia popolare“ del 1876, costituisce una sistemazione razionale –discutibile quanto si vuole ma robusta e illuminante- che nella sua brevità compete con i lavori più corposi dei D’Ancona e Rubieri.
Per mole e completezza il volume del 1888 si impone su tutti gli altri lavori del Nigra. Come è noto - oltre alla prefazione, che è nuova, ed alla stesura definitiva del saggio già pubblicato nel 1876 - esso contiene anzitutto centocinquantatré canzoni storiche, romanzesche, domestiche e religiose, accompagnate da sedici trascrizioni musicali e da un ricchissimo apparato di lezioni varianti, riscontri comparativi italiani ed europei, analisi e commenti storico-filologici; si aggiungono poi una cinquantina tra orazioni e giaculatorie religiose e cantilene, rime infantili e giuochi, centottantatré strambotti, dieci stornelli, un repertorio lessicale. Il tutto si organizza razionalmente attorno ad un principio esplicativo centrale - la concezione 'etnica' della lingua e della poesia popolare, con la connessa nozione di sostrato - e porta ad un fascio di conclusioni che converrà esporre fin da ora, avvalendoci (con integrazioni e precisazioni) della ricapitolazione che già ne fece Gaston Paris nel 1889:
- Dal punto di vista della poesia popolare l'Italia si divide in due zone bendistinte: l'Italia superiore (che comprende «la Liguria, il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia, la Venezia) e l'Italia inferiore (centro-sud e Sicilia). Nell'Italla superiore predominano le 'canzoni' a carattere epico o narrativo ed oggettivo, in versi di misura variabile ma non mai endecasillabica, e con rime o assonanze prevalentemente ossitone ossia Tali canzoni narrative sono fortemente dialettali, non hanno rapporti con la poesia colta, e non presentano carattere amebeico. Oltre che nell'Italia superiore, sono diffuse anche in Francia, Provenza, Catalogna e Portogallo, sia come 'genere', sia come singoli testi più o meno modificati.
Nell'Italia inferiore prevale una poesia lirica ed amorosa che ha due forme, lo stornello e lo strambotto, diverse fra loro per il numero dei versi (tre nel primo e da quattro a otto nel secondo), ma accomunate dal fatto che sono sempre monostrofiche e in versi endecasillabi, con l'eccezione del quinario iniziale di certi stornelli. Tale poesia lirica si riferiscono molt elle qualificatissime pagine che dedicarono a Nigra studiosi della levatura di Domenico Comparetti, Pio Rajna, Alessandro D'Ancona, Gaston Paris, Alfred Jeanroy ecc.
Per mole e completezza il volume del 1888 si impone su tutti gli altri lavori di Nigra.
- Alla distinzione geografica, metrica e di materia poetica corrisponde una sostanziale differenza dei dialetti: prevalentementeossitoni (o tronchi) nell'Italia superiore e parossitoni (o piani) in quella inferiore.
Il complesso di queste differenze dialettologiche, metriche e contenutistiche tra Italia superiore e Italia inferiore si riconduce alla diversità tra le popolazioni che abitavano le rispettive zone prima della romanizzazione, e cioè al substrato o sostrato.
Nell'Italia inferiore «sotto il latino non v'è substrato se non italico», e questo substrato si esprime nel parossitonismo cosi dei dialetti come dei versi ed è perciò anche all'origine di tutte le altre caratteristiche degli strambotti e simili: natura lirica e soggettiva, tematica amorosa, ecc.
Nell'Italia superiore (così come in Francia, Provenza, Catalogna, Por togallo) «sotto il latino v'è substrato celtico» , dal quale appunto na scono l'ossitonismo dellelingue e del metro e la diffusione in tutta l'a rea delle «canzoni celto-romanze», il cui stampo formale e la cui na tura narrativa e oggettiva preesistevano alla romanizzazione.
- Il principio che i canti storici sono coevi agli avvenimenti narrati permette di stabilire che le canzoni non solo sono più antiche delle attestazioni documentarie esterne (che non portano al di là del xv secolo), ma in qualche caso rimontano a tempi assai remoti.
- Il luogo di nascita delle singole canzoni è determinabile con qualche certezza solo se l'area di diffusione è molto circoscritta o se il contenuto offre indicazioni esplicite. Negli altri casi c'è da tener presente che la Provenza è punto obbligato di passaggio per ogni trasmissione orale da una zona all'altra del territorio celte-romanzo (ad eccezione del contatto diretto tra Francia settentrionale e Piemonte).
Il numero delle canzoni certamente nate in Francia e in Provenza permette poi di ritenere che queste siano state le zone piu produttive.
Questa «ardita costruzione storica» ha avuto risonanza soprattutto attraverso al volume del 1888, e quasi esclusivamente ad esso ci si riferisce infatti quando si parla di Nigra come studioso di poesia popolare.
In questo contesto ci sono già gli inizi di tanta futura attività di Nigra: studi celtici, dialettologia, collaborazione con Ascoli e con l'Archivio Glottologico ecc.; ed alla sua luce i Canti del 1854 dichiarano meglio la loro novità e le anticipazioni del lavoro a venire.
Con un tono sorvegliato e sobrio (raro, allora e poi, in questo campo), e senza discorsi generali ab ovo, né tommaseiani né al modo del D'Ancona, Nigra si accosta ai testi, intesi come forme e contenuti specifici, con immediata precisione e con puntuali riscontri già di raggio europeo. E subito segnala la radicale differenza - per contenuto e per forma - tra le canzoni narrative piemontesi e i rispettivi toscani, la diffusione delle canzoni in quasi tutte le regioni dell'Italia superiore ed il loro legame con i -canti degli altri popoli europei-, la difficile penetrazione in Piemonte del rispetto toscano, e le «gravi modificazioni di senso, di lingua, di metro» che deve subire. Quando poi fornisce l'esempio di un rispetto che in Piemonte ha perduto la misura endecasillabica dei versi. Nigra certo pone il primo germe tanto della sua futura concezione etnica della poesia popolare, quanto dei suoi richiami a quella legge darwiniana «di trasfor mazione» o di «adattamento all'ambiente», che menzionerà nel 1876 e nel 1888, e che nel 1889 si rammaricherà di non aver potuto studiare negli strambotti giunti «all'Italia settentrionale dal Mezzodì».
È evidente che la divisione dell'Italia in due aree etnicamente e dialettologicamente distinte poteva entrare in contrasto con il processo di unificazione; e perciò fino al 1870, Roma capitale, Nigra. ed altri studiosi ne tacquero. Nel 1874, invece, Nigra poté scrivere: “L'argomento, di cui entriamo a discorrere, può oramai esser trattato senz'altra preoccupazione, che quella della verità scientifica. L'Italia, per quanto spetta ai dialetti in essa parlati e alla sua poesia popolare, va divisa in due grandi zone, nettamente distinte. Queste due zone si dividono quasi per metà la popolazione Italiana, e comprendono, l'una la Liguria, il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia e la Venezia; l'altra il resto d'Italia. Chiameremo la prima zona Italia superiore e la seconda Italia inferiore.
Italia superiore a sostrato celtico e Italia inferiore a sostrato italico. Due aree dunque per Costantino Nigra. Ma qui debbo notare di nuovo - e lo faccio con vivo piacere per il raccordo che stabilisce tra una delle mie patrie e la patria di Nigra - che nel 1893, a cinque anni dalla pubblicazione dell'opera maggiore di Costantino Nigra, nel remoto Molise uno studente diciannovenne, Luigi D'Amato, poi divenuto chirurgo di fama, in dialogo non solo con lo studioso piemontese, ma con l'intera cultura europea - Paris, Jeanroy, D'Ancona, Mommsen, Ascoli e viadicendo - sviluppava la costruzione nigriana sostenendo che le considerazioni etnologiche non autorizzavano a raggruppare tutta l'Italia, dalla Magra in giù, in una sola grande famiglia a substrato italico. Ed affermava: “Io penso che etnologicamente e etnograficamente nell'Italia cosi det• ta meridionale si debbano distinguere per lo meno due famiglie, una al di qua e una al di là del faro, la italica e la sicula...”
La conclusione è dunque che «in Italia bisogna ammettere tre e non due gruppi di poesia popolare»: la canzone narrativa, lo strambotto amoroso, la satira narrativa. La presenza di quest'ultima, fra i nipoti degli Italioti riempie una grande lacuna, nel sistema del Nigra, e con ciò ne consolida i criteri di classificazione sanissimi e di capitale interesse nelle ricerche folkloristiche.
Costantino Nigra aveva dunque fatto scuola nel Molise. Alla luce della sua impostazione, da una esperienza regionale diretta, nasceva il tentativo di allargare ulteriormente le conoscenze generali; di distaccare lo sguardo dai due soli tipi di canto popolare su cui si fissava l'occhio degli studiosi di allora, cosi come i Canti popolari del Piemonte lo avevano distaccato dall'unico tipo cui l'aveva diretto il D'Ancona.
Piu di centotrenta anni sono passati dall'opera maggiore del Nigra: quale il rapporto con il mondo attuale? Uno ne balza evidente: l'Italia superiore, come Nigra la chiamò, e cioè quella a sostrato celtico con dia letti ossitoni e con canzoni narrative, coincide con quella parte d'Italia che oggi alcuni o molti chiamano Padania, forse senza saper nulla né di Nigra né di sostrato celtico, ma evidentemente non del tutto senza fondamento.
Un altro legame - ma di tutt'altra natura: diretto, consape• vole e fruttuoso - è quello costituito da Il Nigra cantato che è il nome col quale Gianni Bosio, Roberto Leydi ed io progettammo una rilevazione interregionale dei canti narrativi documentati da Nigra e ancora viventi nella tradizione orale.
Dal progetto nacque il disco Il Nigra cantato, vol. 1 °, Donna Lombarda, a cura di Franco Coggiola. Il lavoro del Nigra cantato è stato poi ampliato, rielaborato e riorganizzato da Emilio Jona, Franco Castelli e Alberto Lovatto che ne hanno ricavato due CD, ad arricchimento di questa nuova edizione dei Canti popolari del Piemonte (conforme, per quanto riguarda il testo del Nigra, alle precedenti edizioni einaudiane del 1957 e del 1974).
Ma per il resto? I molti anni mi precludono ogni altro tentativo di attualizzare il lavoro e la personalità di Nigra: sono, per età, piu vicino ai suoi tempi che a quelli in cui io ancora vivo, mio ritardo traendo. Posso solo segnare, ove a qualcuno dicano almeno qualcosa, quattro temi o argomenti: Europa degli studi ed Europa delle genti, o etnie; laicità risorgimentale e laicità della verità scientifica; cristianità del sentire; patria, ossia luoghi, cieli e notti, persone: dal borgo al mondo. Una lezione, dunque, ancora attuale.
Amerigo Vigliermo ed il Centro Etnologico Canavesano (CEC)

Non si può oggi parlare di etnologia e folklore senza citare l’eccezionale opera di ricostruzione della musica popolare che accompagnava i canti, effettuata da Amerigo Vigliermo e da tutti i suoi collaboratori che come Coro Bajolese fondano il C.E.C. nel 1985. L'attività del C.E.C si è sviluppata tenendo conto di quattro momenti, che caratterizzano una corretta indagine sulla Cultura della Tradizione Orale: - La Ricerca, La Restituzione, L'Analisi e L'Archivio delle testimonianze raccolte.
La Ricerca é iniziata nel 1969 per vocazione spontanea di alcuni componenti del Coro, che ritenevano doveroso riproporre i canti della propria Gente, piuttosto che rifare il verso ad altre esperienze corali.
Così abbiamo imparato a conoscere la nostra Gente e preso coscienza della vastità del problema e nello stesso tempo dell'abbondante messe che si poteva ancora raccogliere dalla fertile e generosa memoria dei nostri collaboratori.
Fu cosi che nacque l'idea di fondare il C.E.C., chiamando a collaborare con noi proprio quegli Enti che sono designati dalla Gente stessa.
Prima col magnetofono e la macchina fotografica, poi con la cinepresa e la telecamera abbiamo raccolto testimonianze sui canti, sulle feste, sui riti, sul lavoro, sull'immigrazione e ogni altra espressione riguardante la Gente che vive in Canavese.
Migliaia di testimonianze, ore di registrazione, immagini documentano il nostro lavoro, ma soprattutto ci mostrano il connettivo socio culturale del Canavese antico e moderno.
La Restituzione
Dopo la raccolta, la restituzione attuata con audiocassette (ne sono state realizzate circa 50), dischi, libri, opuscoli e per un certo tempo con una rivista (Gente nel Canavese) ha consentito al C.E.C. di intrecciare un fitto dialogo coi propri collaboratori facendo nascere negli stessi una nuova coscienza culturale delle cose che sapevano.
Ma anche nella scuola, l'esperienza triennale con le insegnanti del 2° Circolo di Ivrea, l'ausilio per la stesura delle tesi di laurea, il C.E.C, ha dato il suo contributo di conoscienza.
La restituzione, che per un certo tempo si è realizzata anche attraverso le emittenti locali (sulla radio eporediese siamo stati presenti fin dal 1976) si è rivelata un mezzo efficace per imparare a conoscere sempre meglio la realtà canavesana.
Da oltre vent’anni organizziamo gli "Incontri del Venerdì" per dare modo ai gruppi e alle persone singole di venire a raccontare in...diretta le proprie esperienze.
Il Coro Bajolese è poi l'ambasciatore del C.E.C, e dei suoi collaboratori là dove viene invitato a cantare.
Abbiamo pubblicato recentemente un’opera che riassume l'attività di ricerca e di restituzione del canto popolare canavesano e piemontese svolta in questi anni.
Costantino Nigra dedicò molti anni della sua vita ricercando e raccogliendo i testi dei canti popolari narrativi pubblicandoli poi, nel 1888, nel libro "I canti popolari del Piemonte", testo che pose senza dubbio una pietra miliare nel campo degli studi etnografici e filologici.
Con questa pubblicazione (15 CD - Vitalità e sopravvivenza della ballata epico-lirica in Piemonte) ricordiamo la sua opera fondamentale che ci ha guidati nella ricerca e raccolta dei canti (non soltanto di quelli da lui annotati) tra la Gente che vive in Piemonte e nello stesso tempo desideriamo rendere omaggio ai cantori che li hanno difesi e che ancor oggi li utilizzano per animare la vita associativa delle borgate in cui vivono.
L’opera è costituita da un cofanetto contenente 15 CD ed un libretto con l’indicazione per ciascun CD dell’indice dei brani, gli esecutori e le località dove sono stati raccolti.
Di ciascun canto narrativo sono presentate tutte le versioni ritrovate in Canavese ed in altri luoghi del Piemonte.
L’Analisi
È la fase più difficile, dove occorre l'ausilio di studiosi delle varie discipline per recuperare i valori ancora attuali contenuti nel materiale raccolto.
L’Archivio
Le migliaia di registrazioni, fotografie e riprese video raccolte in tutti questi anni sono confluite nell’archivio del C.E.C.
Oltre alle registrazioni dei canti (che naturalmente costituiscono una parte importante dell’archivio) ci sono testimonianze sugli usi locali, sui mestieri, sui riti, sulle feste; inoltre fiabe, leggende, indovinelli, proverbi, racconti di vita vissuta (la guerra partigiana, il lavoro, ...).
È in corso il trasferimento delle registrazioni da audiocassette a CD, ed ora stiamo anche pensando al trasferimento delle fotografie (diapositive) e dei video (videocassette) su DVD.
L’archivio dispone di una propria sede con attrezzature quali computer e strumenti di registrazione con i quali continua l’attività di ricerca e di catalogazione.
Le notizie che riguardano le tradizioni popolari sono sempre richiami che riempiono il cuore di allegria e speranza. Veramente quando si sentono queste notizie viene spontaneo di esclamare: meglio tardi che mai!
Pensando all’inizio della attività di ricerca del CEC, avviata nel 1966 colla fondazione del Coro Bajolese e proseguita sistematicamente con magnetofono e macchina fotografica fin dal 1969, vengono alla memoria i sorrisi ironici e le canzonatorie pacche sulle spalle che suonavano come definitiva condanna al fallimento della nostra iniziativa: tanto non troverete niente!
Neppure oggi, con l’archivio pieno di testimonianze di ogni genere, si sentono ripetere quelle “frasi”, che rivelano la profonda ignoranza, sull’argomento, di chi le ha pronunciate.
Al contrario una ricerca seria, che prescinda dall’effimero desiderio di seguire mode e modelli ricorrenti, è sempre da applaudire e sostenere.
Non solo, ma è da estendere a tutte le attività e a tutte gli aspetti della società attuale così profondamente modificata con l’arrivo di immigranti provenienti da mondi così lontani dal nostro.
In sostanza è un’opportunità che si presenta per conoscere realtà difficilmente avvicinabili.
Ma non basta l’articolo sul giornale locale o lo “spot” televisivo, per esaurire il doveroso omaggio al mondo popolare. Occorre proseguire il cammino, non fermarsi alla banalità di un’occasione fugace, seppure suggestiva, di una manifestazione “folcloristica” che lascia il tempo che trova.
A Costantino Nigra va il grande merito di aver riportato alla luce una cultura popolare che si sarebbe certamente persa nel corso dei tempi, organizzandola ed illustrandola intelligentemente.
Gli dedicò Alessandro D’Ancona, altro grande maestro della cultura popolare piemontese, nella dedica della sua opera, pubblicata nel 1876, “La Poesia popolare italiana”, queste belle parole:
a Costantino Nigra
amoroso e sagace illustratore della popolare poesia
degno di rappresentare a straniere nazioni
il nome e l’intelletto d’Italia
in testimonio di antica amicizia
questi studi offre l’autore
I Canti popolari del Nigra visti da Alessandro Vitale-Brovarone, già Professore di Filologia romanza all’Università di Torino
Sia pure in una angusta prospettiva critica e metodologica, l'attività di ricerca e studio dei canti popolari dell'Italia nordoccidentale precedette di parecchi anni la pubblicazione dei Canti popolari del Piemonte di Costantino Nigra e ne accompagnò la stesura e l'elaborazione, protrattasi almeno dal 1854 al 1888. Di questa attività, cui il Nigra riconosce il suo debito, è rimasta soltanto, a quanto mi consta, una tenue traccia di Canti popolari Umbri, Liguri, Piceni, Piemontesi e Latini di Oreste Marcoaldi.
Il Marcoaldi, marchigiano, si servì a sua volta principalmente, per la parte ligure e piemontese, di una raccolta manoscritta di Domenico Buffa, risalente approssimativamente agli anni '40. Tale raccolta, sappiamo ancora dal Marcoaldi, era passata attraverso le mani del Tommaseo, che stava allora raccogliendo materiali per una raccolta di canti popolari di tutte le province italiane. Ma i debiti e le riconoscenze del Nigra vanno oltre:
« Un'altra parte considerevole della collezione [oltre quella costituita dai canti raccolti personalmente], mi fu trasmessa o rimessa da molti collaboratori, alcuni dei quali portano un nome ben noto in Italia. Giovanni Picchia, l'illustre professore di sanscrito nell'Università torinese, mi diede, fin dal 1853, una raccolta di canzoni da lui trascritte in Torino sotto la dettatura di Giuseppina Morra-Fassetti. Domenico Carbone, già compagno di studi e d'armi, non mai abbastanza compianto, mi diede, nel 1858, le canzoni da lui raccolte nel suo nativo villaggio di Carbonara presso Tortona. Domenico Buffa, noto non solo nel campo letterario, ma ben più nella storia politica del nostro paese, mi fece dono, egualmente nel 1858, del suo manoscritto di canti popolari piemontesi e liguri da lui raccolti, dal 1842 al 1845, dal quale Oreste Marcoaldi trasse tutta la parte ligure e piemontese della sua collezione, e in cui mi rimase pur qualche cosa a spigolare. Parenti, amici e colleghi trascrissero per me molte lezioni in varie parti del Piemonte: Teresa Croce, già nominata, in Sale-Castelnuovo nel Canavese; Emerenziana Nigra-Vegezzi-Ruscalla, e Adele Bolens sulla collina di Torino; Enrichetta Cassone in Moncalvo-Monferrato; Felice Oddone in Era; Luigi Bassi in Mondovì, Torino e Pinerolo; Carlo Franchelli, morto sui campi di battaglia a San Martino, nella campagna di Torino; G. B. Gandino in Era e Mondovì; Bernardo Buscagliene in Graglia presso Biella; Garnerone in Lanzo Torinese; D.Monello in Montaldo di Mondovì; Gaudenzio Caire in Pinerolo e Novara; Giuseppe Rossi in Saluzzo; Pietro Fenoglio in Bene-Vagenna di Mondovì; G. B. Amidei in Paesana, Lagnasco, e Val di Po, circondario di Saluzzo; Annibale Strambio in Rocca d'Arazzo, circondario d'Asti. E finalmente due buone collezioni mi furon trascritte, una da Nicolo Bianco in Val-fenera d'Asti, e una da Tommaso Borgogno a La Morrà, circondario d'Alba in Monferrato, mentre egli era colà giudice di mandamento. Qualche canzone mi fu pure trasmessa da Giuseppe Regaldi da Parma, da A. Berti da Venezia, da Cristoforo Pasqualigo da Lonigo nel Vicentino, da Gabriele Rosa da Brescia, da Alessandro D'Ancona da Pisa; altre da altrove».
L'ingresso, a mio giudizio molto proficuo, in questa « zona d'ombra » della cultura piemontese pre-unitaria,
ci è reso possibile dal Nigra stesso che si preoccupò, con l'onestà scientifica che ha lasciato grande impronta
nei Canti popolari del Piemonte, di render pubblico il materiale di cui si era servito. Il Nigra infatti inviò in
dono alla Biblioteca Nazionale di Torino un pacco contenente una buona parte delle raccolte manoscritte che gli abbiamo visto ricordare. I fascicoli e i fogli inviati dal Nigra furono poi legati e sono tuttora conservati tra i manoscritti della Biblioteca Nazionale.
3° articolo: Costantino Nigra Poeta
Carlo Demarchi e Roberto Favero
Carlo Demarchi
Premessa
Come la fama del grande diplomatico risorgimentale, anche quella di Costantino Nigra poeta, pur affievolendosi col tempo, rimane una testimonianza rilevante del livello culturale e letterario di questa straordinaria figura di canavesano puro sangue.
Un certo ripensamento sui modi e sui miti dell’Unità d’Italia ed una evidente sazietà per i toni classici o epici della poesia (lo si è visto anche per poeti più importanti), hanno posto in ombra una figura che si stagliava a tutto tondo nel nostro panorama poetico nazionale.
Ecco la ragione per cui nel 2001, con l’entusiasmo ed il timore dei neofiti, presentammo, come Lions Club Alto Canavese, al pubblico, la terza edizione delle poesie di Costantino Nigra, dopo quella del Sansoni del 1914 accompagnata dall’acuto commento di Alessandro D’Ancona, e quella dello Zanichelli del 1961 con la sobria ma elegante prefazione di Geno Pampaloni, entrambe introvabili.
La presentammo sia per colmare una lacuna, sia per rispondere a numerose richieste intese da più parti.
Non osiamo pensare che i risultati siano stati pari alle aspettative, ma certo l’impegno da noi profuso è stato grande per quanto riguarda la ricerca di eventuali inediti o vecchi commenti, per gli episodi storici, per la selezione delle numerose illustrazioni e fregi, infine per ciò che concerne la presentazione e le note di ogni singola poesia, che nelle edizioni precedenti non esistevano.
Non è stato sempre facile interpretare un testo che suona talora ostico (in senso interpretativo), pur nella sua eleganza, sia perché determinati fatti erano senz’altro più chiari nell’epoca in cui le poesie venivano scritte, sia per i preziosi riferimenti mitologici, sia infine per la raffinata ricercatezza del linguaggio poetico cui siamo ora meno avvezzi. Confessiamo anzi, pur avendo compulsato testi consoni, di non aver probabilmente sempre colto nel segno, per cui non ci resta che confidare nella comprensione degli eventuali lettori più eruditi.
Abbiamo aggiunto alla edizione Zanichelliana quattro componimenti mai pubblicati prima in raccolta e diviso le poesie in quattro gruppi abbastanza omogenei: quelle cosiddette minori, i tre grandi carmi in versi sciolti, gli Idilli e le traduzioni classiche.
Non sono state rispettate in assoluto le date di composizione se non, ove possibile, nei singoli gruppi, anche perché i poeti stessi spesso non le rispettano nelle loro raccolte, preferendo seguire altri criteri.
Ci augurammo che potesse piacere aprire un capitolo nuovo su Costantino Nigra in vista delle celebrazioni del 150° anniversario del Regno d’Italia, occasione che il Piemonte ed il Canavese non dovevano lasciarsi sfuggire per rinverdire la fama di un così importante personaggio.
Noi, modestamente, ma con piena coscienza, intendemmo aprire la strada e a distanza di quasi vent’anni siamo orgogliosi di aver portato a termine un’opera che rende giustizia a Costantino Nigra poeta, facendone comprendere il valore che in alcuni casi è certamente, dal punto di vista poetico, rilevante.
Tutte le poesie del Nigra sono state pubblicate nel 2001 in uno splendido volume commentato, a cura del Lions Club Alto Canavese, e reperibile al Centro Studi Costantino Nigra presso la Biblioteca Civica di Castellamonte.
La Poesia del Nigra
La poesia, salvo quando tratta i grandi temi universali, sempre uguali in tutte le epoche dell’uomo, non può mai prescindere dal momento storico in cui viene creata e dal conseguente stato d’animo del suo compositore.
Costantino Nigra è stato uno dei più convinti ed efficaci artefici dell’Unità d’Italia e pertanto alcune delle sue poesie più celebri risentono del suo spirito guerriero e dell’amor patrio da cui sono state dettate. Sentimenti però che, a nostro parere, non riescono mai a spegnere del tutto l’estro lirico dell’autore.
Nella maturità poi, una volta attenuata l’eco delle trombe e scomparso l’ondeggiare dei vessilli, il Nigra, precedendo di poco la tendenza del Novecento, si ripiega su se stesso e nascono composizioni più intimiste e quiete, con ben altri temi e motivazioni, ed anche la poesia si avvantaggia raggiungendo mete di superiore altezza.
In ogni caso, nelle une come nelle altre, non viene mai meno il magistero del fine letterato, cultore della forma oltre che del contenuto, tanto che, ove questo attenui la sua forza, l’altra sopperisce con risultati apprezzabili.
Come si è detto nella prefazione, le poesie sono state divise in quattro gruppi.
Il primo gruppo comprende diciassette componimenti di varia natura e di date anche molto lontane fra loro. Tra di essi vi è la prima poesia ufficiale del Nigra, l’ “Epitafio d’un amore”, scritta a 17 anni durante il Liceo ad Ivrea per una fanciulla che pare lo avesse abbandonato.
Tra gli altri componimenti spiccano la romanza “Al mio cavallo” e soprattutto la celeberrima “Barcarola” (che, come vedremo, non si chiamava così in origine) scritta per l’Imperatrice Eugenia in favore della liberazione di Venezia, e che suscitò grandi entusiasmi. Vi sono comprese anche le quattro poesie che abbiamo scoperto recentemente:
la canzone “All’Italia” del 1848, uscita su La Gazzetta del Popolo di Torino il 2 luglio 1907, l’ “Epithalamion” del 1851, un imeneo in ben politi versi latini pubblicato sulla rivista Il Baretti del 6 gennaio 1876, l’elegia “ A mia madre” pubblicata in cartolina nel 1928 e “La romanza di Tristano e Isotta” pubblicata nel 1897 su Nuova Antologia.
Gli altri componimenti, di diverso argomento e metro, non aggiungono molto alla fama del poeta, ma vi si nota una sicura padronanza del verso e, sparse qua e là, felici intuizioni di un romantico che, anche nei momenti meno impegnati o meno felici, riesce, se non a provocarci emozioni, ad essere almeno gradevole al nostro orecchio.
Il secondo gruppo contiene i tre importanti carmi in versi sciolti che gli diedero, ai suoi tempi, autentica fama. In essi vi è la prima poesia veramente impegnativa del Nigra.
“Per le nozze di Alessandrina d’Azeglio con il marchese Matteo Ricci” del 1852, di raffinata eleganza e di gusto sicuro, lodata anche dal Manzoni, nonno della sposa, che dichiarò al D’Azeglio: “ fra gli ufficiali del suo Ministero uno ve n’è il quale sa scrivere versi siffatti, che da un pezzo non ne ho letto di eguali”.
Si tratta di 142 endecasillabi sciolti di squisita fattura in cui i critici, ma anche un attento lettore, hanno visto accenti del Monti, del Parini e del Foscolo, autori certamente ben presenti alla mente del Nigra.
Vi è contenuto un brano che è forse il più bell’elogio che mai sia stato scritto per il Canavese in poesia. Il carme fu distribuito a pochi intimi, ma ebbe un tale successo che se ne dovettero stampare molte copie in più e fu pubblicato poi sulla Rivista Il Baretti.
L’ ”Ode in morte di Silvio Pellico”, celebra con affetto fraterno una nobile figura del nostro Risorgimento, che pagò con dieci anni di detenzione, di cui otto di carcere duro nella fortezza dello Spielberg, il suo amore per l’Italia e la sua avversione per l’Austria. In seguito a questa durissima prova, a infelici vicende familiari ed anche a causa della salute malferma, il Pellico si era sempre più defilato dalla lotta attiva e si era via via rinchiuso in una intensa religiosità, suscitando prima il risentimento e poi l’oblio dei più attivi combattenti.
Il Nigra, non dimentico dei suoi meriti, ne mette in risalto le grandi virtù e lo ricorda con sincera commozione. In visita allo Spielberg quando era Ambasciatore a Vienna, lascerà nel registro dei visitatori gli ultimi versi del carme, forse i più belli e sentiti.
Ma il più importante dei tre, quello che immediatamente e per molti anni diede fama al Nigra, è
“La Rassegna di Novara”, scritta con l’animo sincero di grande patriota, ed in cui vengono esaltate la gloria dei soldati piemontesi e quella del loro sfortunato Re, Carlo Alberto.
E’ una visione epica, che ancora oggi ci procura viva emozione e slancio patriottico, anche se talora, come abbiamo già accennato, il messaggio politico può travalicare la poesia, ma mai fino al punto di renderla sgradevole o sciatta.
Qui il suo endecasillabo raggiunge il massimo della perfezione e trova pochi eguali (se si escludono i grandissimi) nella poesia dell’ottocento, pur se gli mancano gli empiti del lirismo carducciano di “Piemonte” o de “ I Sepolcri ” del Foscolo, e se nell’elencare i vari reparti che sfilano vi è certo un descrittivismo a volte un po’ monotono ma certamente commemorativo dei valorosi caduti.
Il terzo gruppo, “Gli Idilli” è quello più apprezzato dalla critica ufficiale.
Abbandonati i toni epici dei carmi, il calore del suo fervente patriottismo, e certe movenze scopertamente romantiche delle composizioni cosiddette minori, il Nigra, oramai anziano e stanco, lontano dagli splendori delle corti dove era passato personaggio ricercatissimo e vezzeggiato, e soprattutto deluso dalla politica, si ripiega su sé stesso e si riavvicina alla quiete della sua terra o a visioni idilliache che toccano e commuovono il suo animo stanco.
Nel volgere probabilmente di non molti anni egli compone i dodici Idilli, definiti “bozzetti poetici” o “quadretti fiamminghi” per la loro eleganza e la precisione dei particolari, e paragonati sovente ai sonetti de “L’ Astichello” dello Zanella, ma in cui si notano anche movenze pascoliane e a volte carducciane.
Con un sorvegliatissimo registro stilistico, come dice il Rapetti, Nigra descrive la pace dei campi, il fiorire ed il mutare delle stagioni, la bellezza dei luoghi, la purezza dell’aria, ma vi cala la presenza dell’uomo, magari con la gravezza della sua fatica, in balia del tempo che spesso ruba ciò che ha dato, lasciando disperazione e talora dura imprecazione.
Non è una voce possente quella del Nigra degli Idilli, ma il gusto, la padronanza del verso, la sincerità dei sentimenti manifestati, non lo fanno mai cadere nella retorica, e gli valgono, senza dubbio, un posto sicuro fra i poeti minori dell’ottocento.
Resta da dire del quarto gruppo, quello delle Traduzioni Poetiche.
Accenniamo appena a quella de “Il Profeta” da Puskin con un risultato, nonostante l’impossibilità del raffronto, che ci pare stilisticamente riuscito.
Occupiamoci invece delle traduzioni maggiori e cioè de “La Chioma di Berenice” da Catullo, con relativa dedica di mano del Nigra ad una sua ammiratrice, e gli inni “A Diana” e “Sui lavacri di Pallade” da Callimaco. Qui veramente il Nigra dà prova di una squisita sensibilità per i classici e di una felicissima predisposizione, già peraltro dimostrata ampiamente, al metro più bello ed elegante della nostra letteratura.
Uomo dal fervido, multiforme ingegno, pur fra i gravosi e talora drammatici impegni politici da cui era preso, si occupò di parecchie discipline, ma mai da modesto dilettante. Profuse anzi in ciascuna di esse la sua grande competenza e la specifica cultura frutto di studi non superficiali e di autentica passione: glottologia, filologia, demo-psicologia, folklore, poesia.
Tutti interessi dettati dall’amor di patria e dall’attaccamento alla sua terra di origine. Un vero patriota che ha dedicato l’intera vita al proprio paese.
NIGRA POETA - di Giovanni Tesio - Studi Piemontesi dicembre 2012 - Vol IX - Fasc.2
Nella vita di Costantino Nigra, la vocazione letteraria (se non immediatamente poetica) fu precoce, come testimonia Michelangelo Giorda, quando ricorda che Nigra nel 1845 si iscrisse alla Facoltà di Legge "un poco di malavoglia, in quanto - così il Giorda - avendo egli fin d'allora il chiodo della letteratura ed il bernoccolo della poesia, avrebbe preferito seguire i corsi letterari e dedicarsi all'insegnamento".
Un "bernoccolo della poesia" che si manifesta in vario modo: sia come lettore, sia come traduttore, sia come poeta in proprio. Ma che si manifesta a fasi, sopravanzato dall'attività diplomatica e dall'attività di ricerca (a parte l'alta competenza di filologo classico, basterebbe il monumento dei Canti Popolari del Piemonte, costruito nell'arco di quasi quarantanni, a fissarne la solida statura di studioso).
Violon d'Ingres, dunque, la poesia per Nigra, che tuttavia va tenuta nel conto di un diletto avveduto ed esperto. Un capitolo certamente minore entro la sua maggiore attività, di diplomatico al servizio prima dell'Italia costituenda poi di quella costituita (in cui non resisto tuttavia a iniettare la malizia del Cajumi "libertino" che in un suo elenco sostiene: "Nigra, che senza le istruzioni di Cavour rende la metà", e naturalmente di ricercatore appassionato e ben munito di paleografia, di dialettologia, di etimologia, di lessicologia, di folklore. Se mai ci sarebbe da dire che quando tutte queste attività si accompagnano - come nel Nigra - da un estro di poesia, possono risultare (oggi come allora) non meno attrezzate, ma forse più appetibili.
Di fatto né i contemporanei né (tanto più) i critici che si sono occupati del Nigra poeta nel corso del Novecento (a cominciare dal D'Ancona che nel 1914 si fece editore delle Poesie originali e tradotte, aggiuntovi un capitolo dei suoi Ricordi diplomatici, presso Sansoni; e dal Croce che nel sesto volume della Letteratura detta Nuova Italia gli riserva un cenno abbastanza distratto. Per arrivare fino al Petrocchi che nel '47 includeva Nigra nell'Antologia della lirica italiana dell'Ottocento allestita con Ferruccio Ulivi e nel '48 ne tracciava un profilo lesto e onesto nel volume Scrittori piemontesi del secondo Ottocento, e infine al memorabile Geno Pampaloni che scrisse una non proprio memorabile introduzione a Le poesie edite da Zanichelli nel '61; dicevo che di fatto nessun critico né dell'Otto né del Novecento ha espresso sul Nigra poeta se non giudizi chiaroscurati, prudenti, addirittura cautelosi.
Tutto sommato coerenti con il giudizio di uno storico di gusto intelligente come lo Chabod, che parlò (lo ricorda Giorda e lo riprende Pampaloni) di vena poetica fievole ma decorosa.
Per intanto - in questa nota che vuole essere più un saggio d'intenti che un resoconto di fatti - bisognerebbe tracciare la pur piccola storia della critica su Nigra poeta, insieme con la storia delle varianti che si diano nel passaggio delle poesie dall'officina (quanto ne resta) alla prima pubblicazione (su giornali e riviste) e poi in volume. Collazioni, datazioni, mutazioni. Tutto ciò che possa avvicinarsi non dico a un'edizione critica, che forse sarebbe troppo, ma a un'edizione ben fondata e annotata. Non senza tacere che vere sorprese non ne dovrebbero dare e che dunque l'edizione Zanichelli (non fosse del fatto che si tratta ormai di un'edizione rara e preziosa) potrebbe di per sé bastare a una lettura di onesta costituzione testuale.
Nigra poeta, allora. Nigra che, a parte le traduzioni in endecasillabi sciolti (La chioma di Berenice, "Elegia di Callimaco dalla versione latina di Catullo" pubblicata con ampi commenti storici e filologici presso U. Hoepli, Milano 1891; gli inni A Diana e Sui lavacri di Pallade di Callimaco, pubblicati da Loescher, Torino 1892; cui, per altra vicenda andrebbe aggiunto, come dice il Giorda, "una graziosa lezione de La romanza di Tristano e Isotta, sta tra l'occasione privata (come documenta Emilio Pinchia, in versi latini scrisse un epitalamio per un amico e compagno d'armi; come documentano le edizioni delle poesie, nel 1852 scrisse il carme Per le nozze di Alessandrina d'Azeglio con il Marchese Matteo Ricci); tra l'occasione privata e la pubblica celebrazione di un evento legato ai fatti risorgimentali (da ricordare il carme In morte di Silvio Pellico, del '54, insieme con il poemetto La Rassegna di Novara, composto nel '61 per celebrare i fasti unitari7); tra l'estemporaneità di un affetto (come le sestine del 1854 al suo cavallo Leardo) e l'allusività mondano-diplomatica (come la celebre Barcarola improvvisata nel 1863 per l'imperatrice Eugenia a Fontainebleau. Tra la vena in qualche modo eteronoma o celebrativa (risorgimentalistica) e la vena "idillica", che resta probabilmente la più persuasiva.
Senza contare che rimarrebbero da datare alcune delle poesie che, sempre per merito del Giorda, furono aggiunte all'edizione Zanichelli, le quali si muovono tra suggestioni che - a non dire del componimento Ai compagni di studi e d'armi morti in battaglia, che una data ce l'ha, il 1849 - farebbero pensare a una più remota e giovanile matrice romantica (la fantasia d'amore di Ma poi?, la caccia "infernale" de La ballata del cacciatore dannato) e a un più disilluso incupirsi dei temi e dei toni che vanno da titoli carducciani quali Nunc lux e Mox nox a bibliche contemplazioni come in Finis cinis:
Invan nella perpetua succession dei secoli
scruta l’umano spirito nella natura immensa;
invan dietro la traccia del vero inaccessibile
con incessante angoscia calcola, osserva e pensa.
Son lieve fumo e cenere la terra e il sol rovente,
cenere e fumo è l'opera dell'egra umanità,
e l'immortal materia, fusa al crogiolo ardente,
come sventrata bombola, polve e non altro dà.
Insomma, molto (ancora) da fare per le poesie del Nigra.
Anche sul versante della cosiddetta intertestualità, perché sul foscolismo di base si sono avvicendate altre suggestioni, che da alcuni critici sono state ipotizzate, ma che vanno verifìcate e studiate: dal Petrocchi, che indicava Carrer per il componimento Al mio cavallo o il Prati per la Rassegna di Novara, ma poi faceva un più complesso discorso di incroci tra Carducci e Pascoli, tra linea melica e linea bozzettistica, tra il settecentesco Vittorelli e l'ottocentesco Zanella (indicato soprattutto nella pagina che introduce alla scelta del Nigra nell'Antologia già citata del '47); o prima ancora dal D'Ancona che sempre per La Rassegna di Novara accennava - pur nella diversità degli esiti - a un impulso venuto da Dall'Ongaro. E poi bisognerebbe ulteriormente indagare entro le tracce romantico-risorgimentali che vanno dal bresciano Scalvini al napoletano Poerio fino a quelle post-risorgimentali che stanno tra Pompeo Bettini ed Enrico Panzacchi, tra Domenico Gnoli e Arturo Graf.
La verità è, Io credo, che proprio il carattere "occasionale" della poesia di Nigra contribuisca a fare di lui un poeta a suo modo mercuriale, difficilmente definibile, perché esposto a (e compromesso con) una sensibilità poeticamente indecisa, del resto non diversamente dalla condizione di tanta della nostra poesia ottocentesca (fino al Pascoli e al D'Annunzio), che annovera molti nomi ma - Carducci a parte - dopo Foscolo e Manzoni nessun vero protagonista. Incerta tra le impennate di un Risorgimento attivistico e le morbidezze di un Romanticismo sentimentale, tra i residui di un classicismo paludato e gli annunci di un incerto realismo, anche la poesia del Nigra patisce di approfondimento e di direzione.
In un primo tempo è adesione patriottica al necessario "riscatto", che s'incrocia con un temperamento colto ed emotivo, capace di dare anche voce a più private e segrete motilità. In un secondo tempo diventa espressione dell'ombra e del disincanto, del rifugio e del riparo. Di certo, nel primo caso non deroga da una sorta di mediaetà celebrativa, in cui si possono, sì, cogliere qua e là tratti di un autentico e non retorico (o encomiastico) sentire (ad esempio, nel carme Per le Nozze di Alessandrina d'Azeglio, la dichiarazione di appartenenza canavesana); nel secondo caso una franca e pur sincera convenzionalità di sguardo, che solo quando è scurita dal dettato, sa riscattarsi nella trasparenza di una ben acuta e amara consapevolezza esistenziale.
Detto questo, se guardiamo specialmente agli Idilli (Idilli in cui sempre all'incanto o semplicemente al décor paesistico fa contrasto l'avviso finale che disdice spesso l'assunto e che sembrerebbe voltare in antifrasi la serenità della visione e dunque del termine che la designa: ossia siamo autorizzati a parlare di "idilli" senza idillio e come spia grammaticale a ricordare la frequenza indicativa dell'avversativa "ma"); se guardiamo agli Idilli, è innegabile che Nigra sappia battere educatamente il suo verso, giocando di contrasto; derogando a tratti sapientemente dalla misura e dal ritmo in studiati enjambements e frequenti décalages, di cui è piccola ma significativa spia metrica la predilezione per la misura sdrucciola; mostrando nel complesso una sensibilità raffinata e sensuale (ad esempio, quel suo sostare alle soglie della femminilità sul punto di sbocciare in Sul pergolato o su quella più ardita e prorompente delle "montanine" che salgono "sull'erte/ cime esultanti" in Alpi e risaie), ma - dentro questa sensibilità - già anche un'attenzione alle pieghe del quotidiano in modi che si potrebbero definire - deducendone, beninteso, ogni effetto d'ironia - pre-crepuscolari.
E per altro anche innegabile che a strofe di nitida fattura altre se ne mescolino di più faticosa e magari retorica concezione (possibile, quantunque da dimostrare, l'affinità con certe atmosfere pastorali della pittura piemontese di secondo Ottocento, dal Pittara all'Avondo e, insomma, la prossimità al "vero naturale" della canavesana scuola di Rivara), come accade ad esempio in Novembre, di cui mi limito a citare due (flagranti) strofe:
Ritto, appoggiato sul bastone,
come sentinella fantastica,
sta il pastor col cappuccio in sulle chiome
immoto all'intemperie.
Nella tasca ha la povera sua mensa,
dura ha la faccia ed ebete,
non favella, non opera, non pensa,
guata stupido ai nuvoli.
Ma nel complesso non discosterei troppo il mio giudizio dal giudizio - onestissimo - che già diede a suo tempo il Giorda: "Un verseggiatore e quasi sempre un ottimo verseggiatore, sì; una natura epica e georgica, anche; uno spirito eminentemente lirico, no". E tuttavia vorrei chiudere questa mia nota con una delle poesie più amabili, in cui si può cogliere nell' "ispirazione" poetica il frutto poeticamente assimilato (e anche un po' pascoliano) del Nigra demo-psicologo, già del resto presente nell' "idillio" di Settembre.
Voglio dire La canzone della nonna:
(In mezzo al mare un'isola c'è
e vi comanda la figlia del Re).
Canta filando l'avola
giù nella stalla. Le tremule note
i bimbi intenti ascoltano.
Sonnecchia in culla l'ultimo nipote.
(Ogni garzone che passa di là
paga dogana e un bacio le da).
Cala di fuori in gelide
falde la neve nella buja notte,
picchia il rovajo e fischia
nell'ultimo fesso e per le lastre rotte.
(Gentil galante nell'isola andò,
la damigella baciare non vuo').
Dura il canto monotono
quant'è lunga la sera, e passan l'ore.
Gli occhi dei bimbi chiudonsi
e la lucerna crepitando muore.
(La damigella suo schiavo lo fa,
se non la bacia, più scampo non ha).
Sulla povera paglia
or dormon tutti, l'uno all'altro accanto,
ma pur dormendo sentono
piano agli orecchi della nonna il canto.
(Gli han dato un letto di porpora e d'or,
e le catene son fatte di fior).
E van sognando l'isola,
l'isola verde e il giovine prigione
e la donzella pallida
che i ricci d'or si pettina al balcone.
(In mezzo al mare un'isola c'è,
e vi sospira la figlia del Re).
E anch'essa alfin la vecchia
dorme, seduta colla testa china,
e sogna che nel cofano
c'è ancor del pane e un poco di farina.
Questo quadretto di genere, che incrocia la realtà e la fiaba, la visività della scena e la musicalità del contrappunto, credo che sia il meglio - nel suo perfetto equilibrio metrico-prosodico — per chiudere su uno studio ancora tutto o quasi tutto da fare.
4° articolo: Costantino Nigra: i suoi studi e le sue molteplici ricerche in campo letterario
di Roberto Favero
Introduzione
Si è già parlato molto di questo illustre canavesano ma non si è completato il quadro di uno studioso che ha allargato i campi delle sue ricerche a materie difficili e per lo più riservate a coloro che hanno le capacità di entrare in argomenti peculiari e complessi.
Nigra studioso era così: profondo, attento, preciso, ben documentato, ed ha lasciato tracce letterarie tipiche di chi affronta argomenti difficili con la consapevolezza di poter svolgere un lavoro degno della qualità più elevata possibile.
Parliamo di: etimologia, glottologia, analisi di dialetti e di lingue del passato, tradizioni popolari e altro ancora, come lo studio del sanscrito.
Il suo maestro di letteratura fu il grande Alessandro D’Ancona, storico e studioso; nato da ricca famiglia di religione ebraica, compì i suoi studi a Firenze; all'età di diciotto anni pubblicò il suo primo saggio sulla vita e le opere di Tommaso Campanella.
Nel 1855 si era trasferito a Torino per frequentarvi i corsi universitari della facoltà di giurisprudenza. Ebbe anche modo di seguire le lezioni di F. De Sanctis su Dante che esercitarono una forte influenza sulla sua formazione, inducendolo ad abbandonare gli studi giuridici per quelli letterari. In Piemonte stabilì e consolidò i legami con gli ambienti torinesi e toscani là emigrati, e in particolare con Costantino Nigra, Giovanni Prati, Eugenio Camerini, rappresentando una sorta di trait d'union tra liberalismo toscano e piemontese, anche in virtù del suo impegno come giornalista politico che culminò con la direzione della Nazione di Firenze che tenne dal 1859, anno del suo ritorno in Toscana, fino al 30 apr. 1860. Coltivava intanto interessi di ordine storico, filologico, letterario e teatrale, collaborando a varie riviste, tra cui: la Rivista di Firenze, fondata da Atto Vannucci, il Passatempo di Pietro Fanfani, la Rivista contemporanea di Luigi Chiala. Dopo aver partecipato alla campagna del 1859 come segretario nella Intendenza militare dell'Emilia, gli fu assegnata nel 1860 la cattedra di letteratura italiana all'università di Pisa che tenne fino al 1900; ruolo al quale affiancò molti altri impegni accademici, dalla direzione della scuola normale di Pisa (1893-1900) all'incarico di insegnamento di esegesi dantesca presso l'università di Pisa (1900-1909).
Alla caduta dei Lorena, il 27 aprile 1859, con il plebiscito che sancì l'annessione della Toscana al Piemonte, tornò a Firenze, dove fu direttore dell'appena fondato quotidiano La Nazione, portavoce del Ricasoli, fino al 1860. Da quell'anno fu docente di letteratura italiana all'Università di Pisa, fino al 1900.
Appassionato e profondo cultore delle tradizioni popolari, D'Ancona seppe portare in questi studi la sua esperienza di filologo e la sua competenza di letterato. Egli fu il primo studioso a riconoscere le origini del canto popolare italiano in Sicilia, e il suo successivo affermarsi in Toscana.
Nel 1891 divenne socio nazionale dell'Accademia dei Lincei, e due anni dopo fondò la Rassegna bibliografica della letteratura italiana.
Nel 1904 fu nominato senatore del Regno. Fu infine sindaco di Pisa nel periodo 1906 - 1907.
Gli interessi letterari del Nigra
Con lo scopo di completare il quadro di questa straordinaria figura canavesana diamo una elencazione di altri interessi letterari che Nigra ebbe nella sua intensa vita di studente universitario prima, di neo impiegato del Ministero degli Esteri poi, e infine di diplomatico di carriera. Nigra seppe alternare a meraviglia gli impegni professionali con le sue passioni culturali che in fondo contribuirono a fare di lui una persona colta assai ambita in tutti i circoli culturali e politici del tempo.
Tanti furono i suoi interessi
Studio del Sanscrito
Fu uno dei suoi impegni letterari durante la frequentazione universitaria a Torino negli anni dal 1844 al 1848. Era così impegnato a voler apprendere quante più nozioni possibili dello scibile umano, che si ingegnò a percorrere tutte le strade che gli si aprivano ed a cogliere le varie opportunità per carriere linguistiche e letterarie.
Si mise a studiare il sanscrito, sulle ali dell’entusiasmo suscitato dai primi studi avviati da Giovanni Flechia di Piverone, precursore di questa scienza nuova. Il Flechia, che era il secondo studioso in Italia ad affrontare, con interessi scientifici, lo studio del sanscrito, una delle lingue dell’antica India (da poco individuata come radice degli idiomi europei), si avvalse dell’ausilio di due giovani discepoli ed a loro dispensava liberamente e gratuitamente ciò che, con maggiore fatica, egli aveva già appreso. Nei tiepidi mattini della primavera del 1847 i rari passanti sui viali del Valentino, a Torino, incontravano spesso il gruppo solitario dei tre studiosi, dei quali il maggiore di età insegnava agli altri due il sanscrito, ed ammiravano la parola animata ed il gesto ispirato del maestro e la reverente attenzione dei due discepoli. Uno di quei discepoli, Giacomo Lignana, divenne poi lui stesso professore di sanscrito nelle maggiori Università d’Italia; l’altro, il più giovane, era Nigra, pieno di voglia di apprendere e di accrescere il suo bagaglio culturale.
In quegli anni Nigra seppe imporsi fatiche negli studi, privazioni nei divertimenti e disagi economici pur di imparare, conoscere, sapere di tutto e di più; una volontà ferrea che temprò il suo carattere per tutta la sua carriera futura.
Studi di Etimologia
L’etimologia è lo studio dell’origine delle parole. Questa voglia di approfondire l’argomento nacque nel Nigra negli anni giovanili, quando frequentava il Collegio delle Provincie ad Ivrea e dove vinse la Borsa di Studio per i corsi universitari a Torino. Sull’argomento ebbe a cimentarsi in diversi studi sull’origine di molti nomi contenuti negli statuti di una trentina di Comuni del Piemonte, studi pubblicati come “Saggio Lessicale di basso latino curiale”.
Ma il lavoro più importante riguarda “L’origine del nome di Ivrea” , pubblicato in –Eporediensia- nel 1900 dalla Società Storica Subalpina, in cui Nigra spiega l’origine del nome di quella che poi definirà la capitale del Canavese.
Non citiamo altre pubblicazioni sulla lingua celtica di cui parleremo successivamente ma sottolineamo l’Inventario dell’Ascoli conservato nel sito http://villafarnesina.it/files/archivio/Ascoli_GI_Inventario.pdf che contiene molti riferimenti a lavori del Nigra.
La pubblicazione “Note etimologiche e lessicali” del Nigra contiene dissertazioni dotte sulle basi dell'Etimologia, proposte sino a quel momento su di una serie di parole francesi e italiane che prendono origini da parole latine.
Studi di Glottologia
Fu allievo di Graziadio Isaia Ascoli, linguista e glottologo, con cui collaborò mediante pubblicazioni sull’Archivio Glottologico Italiano, rivista da lui fondata nel 1873 ed una delle più antiche riviste di linguistica edite in Italia.
La conoscenza di linguistica del Nigra gli consentiva di dialogare con scrittori e poeti per approfondire le parole usate nei vari componimenti e spiegare se erano state usate appropriatamente. Documentato uno scambio letterario tra Nigra e Pascoli sui contenuti delle “Myriciae”.
Così Nigra scrive del Pascoli il 26 luglio 1894:
“Devo a Lei l'aver potuto leggere e gustare i versi latini di Giovanni Pascoli, i quali a me lontano dall'Italia difficilmente avrebbero potuto giungere direttamente. Adunque in primo luogo ringrazio Lei, e in secondo luogo La prego di far giungere al Pascoli i miei vivi ringraziamenti congiunti a sincera ammirazione. Dalla lettura delle Myricae io già mi ero accorto che il Pascoli doveva essere famigliare con Orazio e con Virgilio. Ora poi vedo che scrive i versi latini con quasi eguale eleganza che gl'italiani. Non posso dirle abbastanza quanto conforto io tragga dal vedere i nostri giovani letterati dar opera allo studio dei classici Greci e Latini. Il quale studio giova non solo a scriver bene l'italiano, e a pensare chiaramente, ma anche a formare il carattere. Si può trarre da questo fatto un qualche auspicio che la futura Generazione, ammaestrata in tali discipline, riesca migliore di quella che è preceduta alla mia. Anche nello scrivere in latino il Pascoli obbedisce alla mania innovatrice della grafia fin qui ricevuta. Certo non è gran male lo scrivere uvula vulva con tre «««, come fa qualche recente tedesco. Ma il nostro bravo poeta dovrebbe sapere che il dare un solo e medesimo segno grafico a due lettere ben distinte, di cui una è vocale e l'altra consonante, e ciò mentre si hanno, conservati da lunga consuetu-dine due segni distinti, è proprio il voler fare l'erudito fuor di luogo. So anch'io che le vecchie iscrizioni romane, e i più antichi manoscritti usavano un segno solo. Ma allora tanto vale lo stampare il latino in lettere unciali, senza punti e virgole, senza maiuscole, e 7 senza intervalli fra una parola e l'altra, giacché cosi si fa nelle vecchie iscrizioni e nei Mss. Il Pascoli è abbastanza gran poeta italiano per non aver bisogno di sgrammaticare scrivendo de lo, a la etc. e scrive troppo bene il latino perché gli occorra confondere la « vocale con la v consonante, per far piacere a qualche pedante tedesco. Voglia gradire, La prego, i miei distintissimi ossequii. Nigra P. S. — Non amo Virgo roseo vertice fulgida, quali che possano essere gli esempii a cui tale dizione si appoggi. Gli esempi dei classici sono di due specie, i buoni e i cattivi. Bisogna scegliere i buoni — Vertex è il sommo della testa, e prenderlo per le guancie è improprio.
Studi di Lingue antiche
Citiamo uno studio dal titolo: “Glossae Hibernicae veteris codicis taurinensis” in cui spiega le origini della lingua degli antichi Celti che trae le proprie radici da antiche lingue italiche.
Il lavoro più rilevante Nigra lo svolge con la pubblicazione “Le reliquie Celtiche” in cui affronta lo studio del documento conservato alla Biblioteca svizzera di San Gallo. La Biblioteca del monastero di San Gallo è una delle più antiche biblioteche monastiche del mondo, nonché la parte più importante del patrimonio mondiale dell’UNESCO dell'area abbaziale di San Gallo. Il suo prezioso fondo mostra lo sviluppo della cultura europea e documenta l'attività culturale del monastero di San Gallo dal VII secolo fino alla soppressione dell'abbazia, avvenuta nel 1805. Il cuore della biblioteca è costituito dalla collezione di manoscritti, con il suo straordinario corpus di manoscritti carolingi-ottoniani (dall’VIII fino all’XI secolo), una significativa collezione di incunaboli e un fondo crescente di opere a stampa dal XVI secolo fino ad oggi. Nigra esamina e commenta il Manoscritto Irlandese di San Gallo, conservato nella Biblioteca di San Gallo in Svizzera che riporta un testo celtico con la traduzione latina.
Questo importante documento consente di fare luce sulla lingua celtica e sulle sue origini e Nigra dà nuovamente misura delle sue grandi capacità di studioso di dialetti e lingue che si basano sulla sua profonda conoscenza del latino e del greco.
Studi di Dialetti
Nigra ebbe anche ad occuparsi dei dialetti della Val Soana e di Viverone con specifici documenti che ne spiegano l’origine.
Il lavoro più importante però è rappresentato dal “Vocabolario valdostano” in cui elenca alcune migliaia di vocaboli dialettali con il loro significato. Questo lavoro fu pubblicato dal Nigra stesso nel 1906. E' una testimonianza di affetto verso la terra natale (Il Canavese nel 1800 era Provincia di Aosta). Nigra si avvale della collaborazione di un esperto di dialetti della Valle d'Aosta, l'abbé Jean-Baptiste Cerlogne, nato a Saint-Nicolas, nel villaggio di Cerlogne, il 6 marzo 1826 e morto poi nel 1910. Nel 1879 occupa la Rettoria di Saint-Jacques d'Ayas e prepara tutto il materiale per il suo dizionario e la sua grammatica in patois. Nel 1889 diventa rettore alla Trina di Gressoney. Sempre seguito dalla sua vecchia domestica, dal suo gatto e dalla sua stampatrice, Cerlogne occupa poi il posto di cappellano in diverse parrocchie del Piemonte. Nel 1901, diventa rettore di Vieyes, villaggio tra Aymavilles e Cogne. Il suo lungo viaggio termina presso il Priorato di Saint-Pierre.
Tradizioni Popolari
L’amicizia con Delfino Orsi, giornalista e scrittore, lo spinge ad una serie di pubblicazioni in cui Nigra intende documentare le tradizioni della propria terra natale, ossia quelle legate alla Rappresentazioni popolari legate alla nascita ed alla Passione di Cristo, che annualmente venivano effettuate in Valle Sacra.
Nel 1894 viene alla luce “Il Natale in Canavese”, poi nel 1895 “La Passione in Canavese” e infine nel 1896 “Il Giudizio Universale” tutti editi da Roux.
Questi documenti vennero poi riediti diverse volte nel corso del 1900 a cura della Comunità Montana Valle Sacra.
Nell’introduzione dell’edizione de “Il Giudizio Universale” del 1996, il professor Pier Carlo Grimaldi, già professore ordinario presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo-Bra, dove ha insegnato Antropologia culturale e Antropologia e memoria e di cui fu Preside dal 2011 al 2017, così scrive:
“A cent'anni esatti dalla stampa del Giudizio Universale in Canavese, pubblicato e commentato da Costantino Nigra e Delfino Orsi per i tipi della casa editrice Roux Frassati e C. di Torino (1896), viene opportunamente proposta la ristampa dell'opera etnografica che completa la trilogia sulle Rappresentazioni popolari in Piemonte. Sono infatti già state ristampate dalla casa editrice Forni di Bologna -Il Natale nel Canavese- (1894-1982) e -La Passione nel Canavese- (1895-1982), mentre la ricerca più conosciuta e più importante del Nigra, che segna una svolta nella storia del folclore regionale italiano e lo connette ai fervidi studi europei dell'epoca, -I canti popolari del Piemonte-, apparsa nel 1888 per i tipi della casa editrice Bocca, è stata riproposta da Einaudi (1957) e più recentemente anche in edizione economica (1974).
Costantino Nigra, introducendo lo studio del -Giudizio universale canavesano- con la predizione dell'apocalisse , coglie dunque il tratto profondo che porta il contadino a riprendere, a rappresentare e a vivere tale dramma e nel contempo suggerisce di affrontare, in una prospettiva millenaristica, il recente fenomeno di riviviscenza delle rappresentazioni sacre.
Costantino Nigra conduce un’analisi storico-filologica del testo popolare del –Giudizio Universale- alla ricerca dell’originale avvalendosi dell’impianto metodologico già utilizzato per studiare i Canti popolari. Criterio che, come sintetizza Alberto Mario Cirese, lo porta a concludere che, -lo studio di una canzone e delle sue vicende nel tempo e nello spazio non è la storia del tema o argomento della canzone stessa, ma è la storia del testo di quella canzone e delle sue variazioni attraverso il tempo e lo spazio-.
Non ci sarebbe da stupirsi se tra le attuali forme del teatro sacro si recuperasse pure quella del Giudizio Universale, alla ricerca di un moderno Anticristo da esorcizzare”.
Questa rappresentazione, fatta diverse volte in Canavese, trae le sue radici sui Monti biellesi e precisamente a Sordevolo dove si rappresentava anche “La Passione” su testi popolari assai simili a quelli delle rappresentazioni in Canavese.
Il giudizio Universale fu anche rappresentato a Fano nel 1819 e Nigra ebbe quel testo grazie all’interessamento di Alessandro D’Ancona, altro studioso benemerito delle tradizioni popolari.
Tantissime comunque le sacre rappresentazioni della settimana santa sia in Piemonte che in Valle d’Aosta come appare dalla cartina seguente.
